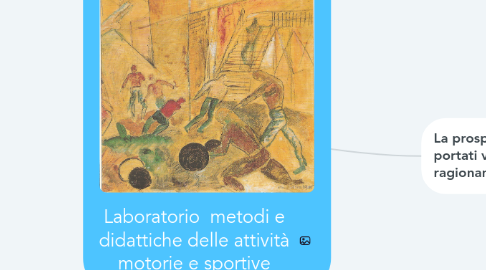
1. GRUPPO 3
1.1. lettura e note a margine del testo di Vygostskij
1.1.1. Uno dei cardini del discorso sta nel concetto di integrità, dal latino "In-tangere"= ciò a cui nulla è stato tolto
1.1.1.1. tale contesto semantico ha un valore pratico perchè va visto in modo retroattivo: il deficit non identifica il soggetto. Il deficit va visto come creato nella reciprocità sociale
1.1.1.1.1. il funzionamento, per associazione mentale e per associazione tra processi, verifica che essi sono tutti interrelati. La finalizzazione delle risposte individuali agli stimoli sociali rende l'idea della connettività e dell'intelligenza come ricchezza delle capacità
1.1.1.1.2. è possibile lavorare per una fortificazione delle capacità, per la trasformazione individuale (legge della compensazione) che sia di stimolo per la crescita
1.1.1.1.3. ci si può appoggiare alla volontà del desiderio di crescita e di sviluppo
1.1.1.2. il processo educativo non "attenua" il deficit. Come in passato: si è tentato di piegare i soggetti con diversa abilità alla educazione secondo norme standardizzate - ciò è stato causa di insuccesso
1.1.1.2.1. una visione positiva della disabilità: uno sviluppo buono e di senso è possibile
1.1.1.2.2. non tutti però sono in grado di recuperare aspetti di senso a partire da una mancanza:
1.1.2. in una situazione di difficoltà ognuno di noi mette in campo tutta una serie di risorse che lo aiutano a superarla positivamente
1.1.2.1. Quando una possibilità non è data una volta per tutte, e ognuno di noi non è in grado di affrontare una situazione di difficoltà traendone anche degli elementi di senso e di significato
1.1.2.1.1. ripensare i propri obiettivi in termini NON MINORATIVI O PEGGIORATIVI, ma strutturarne una diversa in relazione alle difficoltà istituente la crisi, fronteggiandola normalizzando la propria vita
2. GRUPPO 4
2.1. testo 1, Montuschi 1997
2.1.1. Il prezzo della gratuità della inclusione
2.1.1.1. apprendiemento e socializzazione: fattori inizialmente disgiunti
2.1.1.1.1. le due cose sono indistinguibili. La socializzazione non può essere disgiunta dall’apprendimento e l'apprendimento coinvolge le relazioni della persone.
2.1.1.2. la scuola è tenuta a risultare efficace per entrambi gli elementi
2.1.1.2.1. scuola "arricchita", soprattutto per “particolari allievi”
2.1.2. La "certificazione"
2.1.2.1. vantaggio e risorsa per la scuola e la famiglia?
2.1.2.1.1. “Patrimonio”: risorsa potenziale e attuale che garantisce all’istituzione scolastica risorse economiche, competenze culturali e personali, risorse aggiuntive crescenti.
2.1.2.2. stigma sociale?
2.1.2.2.1. l'alunno si identifica con la sua diagnosi, e viene emarginato, la personalità dell’alunno diventa la sua diagnosi
2.1.2.3. come VINCOLO
2.1.2.3.1. anticipare le risorse potenziali...
2.1.2.4. la pedagogia speciale non è lo strumento tecnico per ottenere il diritto, ma uno strumento cognitivo e pedagogico
2.1.2.4.1. la "Persona" va immaginata dalla scuola ancor prima che i bisogni emergano
2.2. testo 2, Bertolini 1994
2.2.1. antitesi e analogia pedagogia e medicina
2.2.1.1. si intrecciano e sono utili allo sviluppo della persona: “scienze dell’uomo e per l’uomo”
2.2.1.1.1. soggettività (pedagogia)
2.2.1.1.2. relazione corpo/mente (medicina)
2.2.2. le definizioni e le diagnosi sono "cose" che trovano un orizzonte comune nel concetto di salute
2.2.2.1. dall'educazione viene la qualità della vita
2.2.2.1.1. concetto di benessere
2.2.3. scopo a breve termine la medicina
2.2.4. scopo a lungo termine in termini di salute
2.2.5. VIVERE LA VITA NEL MODO MIGLIOR POSSIBILE
2.2.5.1. ciascun individuo non ha solo la versione corporea e materiale. Ha un vissuto che lo costituisce nel qui ed ora
2.2.5.1.1. come quello messo in atto dal medico e dall'educatore
3. La prospettiva di lettura del testo ci ha portati verso la complessità, ed il ragionamento ecologico di Morin
4. GRUPPO 1
4.1. Procedimento: lettura collettiva e nota a margine; elenco punti
4.1.1. Il bambino non è "altro" da noi, nè superiore nè inferiore all'adulto
4.1.1.1. Rispetto del bambino
4.1.1.1.1. L'insegnamento è "arte", metodo, per educare
4.1.1.1.2. Educazione pratica e morale
4.2. Pedagogia come scienza aperta
4.2.1. scienza esatta
4.3. Metodo circolare
4.3.1. Il metodo risulta "circolare": parte dall'osservazione della fisiologia del movimento e del gesto (ossia atto stimolo di risposte prestabilite, non intenzionale e mancante all'inizio del "tempo educativo") per giungere alla cognizione e alla consapevolezza del gesto, e infine al riconoscimento dell'opportunità di compiere il gesto
4.3.1.1. Focus sul termine della "circolarità" frutto dell'adattamento e dell'anticipazione rispetto al comportamento adattivo (ad esempio: gli atti motori vengono regolati di continuo attraverso l'ininterrotto flusso delle informazioni sui risultati ottenuti)
5. GRUPPO 2
5.1. Procedimento: lettura collettiva e sottolineatura dei passaggi. Utilizzo dei "commenti a margine"
5.1.1. Concetto cardine quello dell'unicità dell'educando, perchè si parla di persone singolari, di una storia personale e di vissuti individuali
5.1.1.1. il contesto è quello del rapporto tra famiglia e bambino e del potenziamento, dello sviluppo del potenziale, da fare emergere
5.1.1.1.1. Il concetto di Universal design for learning prevede il lavoro a priori necessario per tale operatività.
5.1.1.2. Il sentimento sociale, un altro concetto cardine (Montessoriano), è quello da far emergere nel bambino, perchè non è parte di lui ab origine
5.1.1.2.1. Tutto il concetto del rapporto tra individuo e collettività.
5.1.2. Un altro concetto è quello di sapere co-costruito
5.1.2.1. Séguin parlava di corpo energetico, e di corpo in relazione costrutto del funzionamento cognitivo
5.1.2.1.1. L'adattamento al contesto e al cambiamento vale anche nel campo sportivo, con lo sviluppo di competenze...
5.1.3. L''educabilità e la potenziabilità a qualcosa a che vedere con un'origine perturbante. Il perturbamento sviluppa qualcosa di originale
