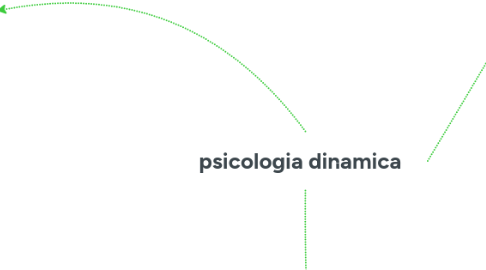
1. LIBRO A SCELTA
1.1. L'IO E I MECCANISMI DI DIFESA ANNA FREUD
1.1.1. DEFINIZIONE E RUOLO DELL'IO
1.1.1.1. L'io è visto da Sigmund Freud esclusivamente come il mediatore tra Es e Super-io e concentra l'analisi nel cercare di capire l'es, per Anna invece come l'io si difende dalle pulsioni è un oggetto di studio fondamentale per capire il funzionamento della psiche
1.1.2. MECCANISMI DI DIFESA GENERALI
1.1.2.1. DEFINIZIONE
1.1.2.1.1. i meccanismi di difesa sono strategie inconsce usate dall'io per ridurre l'angoscia, servono a mantenere l'equilibrio psichico, sono essenziali per il normale funzionamento mentale
1.1.2.2. CLASSIFICAZIONE
1.1.2.2.1. Meccanismi di difesa identificati da Sigmund Freud
1.1.3. L'IO COME OGGETTO D'ANALISI
1.1.3.1. RAPPORTO IO E L'ANALISI
1.1.3.1.1. l'analista per studiare l'io si può trovare di fronte a 3 tipi di situazione
1.1.3.2. DIFESA CONTRO LE PULSIONI E AFFETTI
1.1.3.2.1. Minacce interne (Es) L’Io percepisce alcuni impulsi dell’Es (desideri sessuali, aggressività, desideri inaccettabili) come pericolosi o moralmente inaccettabili. Per evitare il conflitto interno e il senso di colpa (imposto dal Super-Io), l’Io utilizza i meccanismi di difesa (rimozione, sublimazione, razionalizzazione, ecc.). Esempio: un bambino prova rabbia verso un genitore, ma la rimuove perché sarebbe inaccettabile ammetterlo.
1.1.3.2.2. Minacce esterne (realtà) Il mondo esterno può presentare situazioni spiacevoli, come critiche, rifiuti o divieti imposti dalla società. L’Io cerca di proteggersi regolando le emozioni e riducendo l’impatto degli eventi negativi. Esempio: un bambino impara a reprimere il pianto per evitare di essere rimproverato
1.1.4. SPECIFICI MECCANISMI DIFENSIVI E IL LORO CONTESTO
1.1.4.1. RINNEGAMENTO NELLA FANTASIA
1.1.4.2. Negazione della realtà
1.1.4.2.1. Il rinnegamento è un meccanismo di difesa in cui l'Io rifiuta di riconoscere una parte della realtà spiacevole, sostituendola con una versione fantasiosa che soddisfa i desideri dell'Io. Questo permette all'Io di sfuggire all'angoscia.
1.1.4.3. RINNEGAMENTO TRAMITE PAROLE E ATTI
1.1.4.4. IDENTIFICAZIONE CON L'AGGRESSORE
1.1.4.4.1. identificazione con l'aggressore come difesa: Quando un bambino è minacciato o vittima di aggressioni, può reagire assumendo il ruolo dell'aggressore. Invece di rimanere nella posizione di vittima, il bambino si identifica con l'aggressore per ridurre l'angoscia. Questo processo consente al bambino di trasformare l'esperienza di vulnerabilità in una forma di controllo, passando dal ruolo passivo a quello attivo. L'aggressione, inizialmente subita, viene ripetuta dal bambino su un altro compagno, permettendo una sorta di "vendetta" psicologica.
1.1.4.5. ALTRUISMO DIFENSIVO
1.1.4.5.1. L’Io, per evitare di affrontare direttamente desideri o emozioni negative (come aggressività, colpa o desideri egoistici), li trasforma in comportamenti altruistici. In questo modo: Evita il conflitto interno: Se una persona ha desideri egoistici o aggressivi, invece di riconoscerli, li trasforma in un eccesso di premura verso gli altri. Scarica emozioni negative: Proiettare sugli altri il bisogno di aiuto permette alla persona di sentirsi moralmente superiore o utile, riducendo il senso di colpa o ansia. Migliora l’immagine di sé: Aiutando gli altri, l’individuo rafforza un’immagine positiva di sé stesso, compensando eventuali aspetti della propria personalità che non accetta.
1.1.5. LA PUBERTÀ E I CONFLITTI PULSIONALI
1.1.5.1. IL CONFLITTO ES IO DURANTE LA PUBERTÀ
1.1.5.1.1. Durante la pubertà, l’Es diventa più attivo a causa delle pulsioni sessuali emergenti. Il Super-Io, formato dalle norme morali e sociali, può opporsi con sensi di colpa o vergogna. L’Io deve quindi trovare strategie per gestire questo conflitto senza essere sopraffatto.
1.1.5.2. MECCANISMI DIFENSIVI SPECIFICI DURANTE LA PUBERTÀ
1.1.5.2.1. ASCETISMO
1.1.5.2.2. INTELLETTUALIZZAZIONE
1.1.5.3. RELAZIONI OGGETTUALI E IDENTIFICAZIONE DURANTE LA PUBERTÀ
1.1.5.3.1. Rottura con oggetti d’amore infantili e formazione di nuovi legami basati più sull’identificazione (narcisismo) che sul possesso. La crisi nei rapporti oggettuali, il rischio di isolamento e la possibilità di una ristrutturazione dell’identità affettiva
1.1.5.4. ANGOSCIA PULSIONALE
1.1.5.4.1. Angoscia Pulsionale: La paura che deriva dalla potenza incontrollata delle pulsioni. L’Io reagisce raddoppiando i meccanismi difensivi (ascetismo, intellettualizzazione) per proteggersi.
1.1.6. CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE
1.1.6.1. Un buon funzionamento psichico non significa eliminare i meccanismi di difesa, ma renderli flessibili e adattivi.
1.1.6.2. Quando i meccanismi diventano rigidi, possono portare a nevrosi o altri disturbi psicologici.
1.1.6.3. Il terapeuta deve aiutare il paziente a prendere consapevolezza dei suoi meccanismi di difesa.
1.1.6.3.1. Il compito non è eliminare le difese, ma renderle più adattabili e meno rigide.
2. AUTORI
2.1. FREUD
2.1.1. VITA AUTORE
2.1.2. ELEMENTI FONDAMENTALI
2.1.2.1. DETERMINISMO PSICHICO
2.1.2.1.1. qualunque problema, trauma o conflitto che tu avrai durante l’infanzia, inevitabilmente rappresenterà un bagaglio che ti condizionerà durante l’età adulta (“noi siamo quello che è accaduto durante l’infanzia”). Nulla avviene per caso per quanto possa essere incomprensibile, ogni evento psichico è determinato da quelli che sono avvenuti in precedenza ed influenzano quelli successivi.
2.1.2.2. COSCIENZA
2.1.2.2.1. la coscienza è un attributo eccezionale e risente in maniera massiccia di tutto ciò che è sommerso e che non arriva alla consapevolezza (noi pensiamo di sapere tutto, ma in realtà non è così).
2.1.2.3. INCONSCIO
2.1.2.3.1. fenomeno stabile e permanente, sede di forze dinamiche che s’impongono nei comportamenti. Da qui facciamo riferimento a qualcosa di illogico, ma che in realtà “illogico” non è
2.1.2.4. PROIEZIONE
2.1.2.4.1. attribuisco a qualcun altro degli aspetti di me stesso che non accetto (es. sono nervoso, ho una discussione con un’altra persona e gli dico: “oggi sei nervosissimo…”).
2.1.3. CONCETTI
2.1.3.1. STIMOLO
2.1.3.1.1. (ESTERNO): è un qualcosa che ha che fare con l’emotività che, dall’esterno, induce uno stimolo sensoriale immediato (qualcosa di esterno suscita dentro di noi lo stimolo che, di conseguenza, dà il via ad un comportamento e ad una reazione). Un evento, dall’esterno, induce in noi un’esperienza sensoriale immediata; lo stimolo è quindi un input esterno che produce dentro di noi una risposta alla quale rispondiamo.
2.1.3.2. PULSIONE
2.1.3.2.1. (INTERNO)*: è uno stimolo interno (forza/energia mutevole), che quindi trae origine dall’interno del corpo. La pulsione è un concetto “limite” fra lo psichico e il somatico. La pulsione, che proviene dal corpo, si “trasforma” in qualcosa di mentale (trasforma ciò che è corporeo in psichico - parte dal corpo, ma poi si traduce in un contenuto mentale). La pulsione spinge l’individuo ad agire e ad attuare dei comportamenti al fine di far cessare la sensazione di “pressione interna”. Questa forza è strettamente associata al soddisfacimento del bisogno. Chiaramente il bisogno non può essere sempre soddisfatto immediatamente, è influenzato dunque dalla società.
2.1.3.2.2. ELEMENTI
2.1.3.2.3. NATURA
2.1.3.3. ISTINTO
2.1.3.3.1. è la capacità di reagire a un insieme di stimoli (Io reagisco automaticamente ed in modo istintuale ad uno o più stimoli). L’istinto, secondo Freud, è determinato dall’ereditarietà ed ha dunque una “stoffa” di tipo genetico (anche qui ritorna il concetto darwiniano). Sia l’istinto che la pulsione hanno il ruolo di soddisfare un bisogno, con la differenza che l’istinto è sempre automatico, mentre la pulsione può essere regolata da fattori culturali e sociali.
2.1.4. TAPPE
2.1.4.1. ISTERIA
2.1.4.2. TRAUMA
2.1.4.3. DESIDERIO SESSUALE
2.1.4.4. METAPSICOLOGIA
2.1.4.4.1. È sia un approccio che un’opera che cerca di individuare le basi inerenti al comportamento umano. Freud, per spiegare il comportamento umano, dapprima analizza la coscienza, successivamente analizza i processi psichici da tre punti di vista: dinamico, economico e topologico
2.1.4.4.2. PUNTI DI VISTA
2.1.5. CONFLITTO
2.1.5.1. l conflitto è un qualcosa che caratterizza ognuno di noi; la malattia non è solamente “danno organico”, può quindi non avere un corrispettivo biologico. Il conflitto si verifica quando nel soggetto si contrappongono esigenze interne contrastanti che scatenano una “lotta” tra o nelle tre strutture della personalità
2.1.5.2. ESTERNI
2.1.5.2.1. esterni: il conflitto si scatena tra l’individuo e alcuni aspetti dell’ambiente in cui vive
2.1.5.3. MANIFESTI
2.1.5.3.1. il conflitto è cosciente (“Io so di essere andato in conflitto”: ho voglia di mangiare un piatto di pasta, però non posso perché devo dimagrire)
2.1.5.4. LATENTI
2.1.5.4.1. latenti: ha luogo sotto il livello della coscienza (non sono consapevole di avere un conflitto, un giorno mi alzo e ho un sintomo senza substrato organico).
2.1.6. MECCANISIMI DI DIFESA
2.1.6.1. nell’Io vi è sia una parte conscia che inconscia. Quando l’Io si sente in pericolo, e quindi esperisce angoscia, deve prepararsi ad affrontare il pericolo. E come si difende? Lo fa mettendo in atto i meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa, dunque, appartengono alla parte inconscia dell’Io, anche se ve ne sono alcuni che “stanno a cavallo”, ovvero sono parzialmente consci. Il protagonista assoluto dei meccanismi di difesa è l’Io! I meccanismi di difesa sono strategie, a volte poco produttive, per tenere lontano e per fronteggiare efficacemente l’Es. Essi sono volti a preservare l’apparato psichico dell’individuo e sono prevalentemente inconsci.
2.1.6.2. RIMOZIONE
2.1.6.2.1. È l’operazione con la quale l’Io cerca di respingere (o mantenere) nell’inconscio rappresentazioni legate ad una pulsione, in quanto il soddisfacimento della pulsione stessa rischierebbe di provocare una situazione di dispiacere. La rimozione opera al di fuori dalla consapevolezza, anche se i contenuti possono diventare consci attraverso il lavoro analitico. Non bisogna confondere la rimozione con la REPRESSIONE (che è conscia).
2.1.6.3. SUBLIMINAZIONE
2.1.6.3.1. Consiste nella neutralizzazione e soddisfazione libidica e aggressiva che viene deviata verso nuovi scopi o oggetti socialmente più accettabili dall’Io e dal Super Io. Dal latino “sublimare” significa “porre in alto”.
2.1.6.4. SPOSTAMENTO
2.1.6.4.1. L’energia pulsionale viene trasferita da una rappresentazione all’altra (es. seno materno = ciuccio - nell’infante, seno materno = sigaretta - in età adulta). In sintesi: io non riesco a soddisfare la mia pulsione e, di conseguenza, individuo un sostituto e sposto la mia carica pulsionale su un altro oggetto. È come se noi rendessimo “maneggiabile” un qualcosa che in realtà non lo è.
2.1.6.5. PROIEZIONE
2.1.6.5.1. È un meccanismo di difesa arcaico utilizzato come difesa in situazioni di conflitto e consiste nell’attribuire agli altri desideri, tendenze, rappresentazioni che non si vuole riconoscere come proprie. La proiezione è attiva nei primi anni di vita del bambino, in fenomeni non patologici (es. superstizione, razzismo, gelosia ecc.) e nel lavoro psicoanalitico. Un uso massiccio della proiezione è riscontrabile nelle forme paranoidi: l’Io proietta sulla realtà esterna i contenuti minacciosi interni, quindi si difende costruendo un mondo persecutorio più tollerabile di quanto non sia la percezione della propria distruttività. Anche nella fobia esistono i processi proiettivi. Se la proiezione non opera correttamente comporta la perdita dell’esame di realtà.
2.1.6.6. REPRESSIONE
2.1.6.6.1. Questo meccanismo di difesa non viene discusso esaustivamente da Freud (ne fa solo un accenno). La repressione è un processo cosciente che non va confusa con la rimozione. Vi è una presa di posizione consapevole da parte del soggetto a rinunciare a un qualcosa che può apportare un disagio. La repressione può essere considerata come un “fallimento” della rimozione.
2.1.6.7. IDEALIZZAZIONE
2.1.6.7.1. Linguaggio comune: “hai idealizzato quella persona…” - “è troppo buono, non può farmi questo…” L’idealizzazione è un meccanismo di difesa mediante il quale l’Io investe gli oggetti esterni o il Sé in maniera totalmente positiva. Tali oggetti sono appunto “idealizzati” con lo scopo di proteggere l’individuo. Ha l’obiettivo di proteggere l’io da un’aggressività del mondo esterno che il soggetto sente come distruttiva. L’esito può essere la costruzione di immagine di sé e di altri irrealistiche.
2.1.6.8. ISOLAMENTO
2.1.6.8.1. “Mi devo un attimo isolare, devo staccare un momento da tutto questo caos…” Esempio: quando qualcuno ci sta parlano oppure ci chiede qualcosa e noi sembriamo essere da un’altra parte, abbiamo la “testa fra le nuvole” (in sostanza, ci isoliamo). L’isolamento è il meccanismo di difesa mediante il quale un pensiero o un comportamento viene privato delle sue connessioni con altri pensieri o comportamenti, oppure viene “svuotato” del suo significato affettivo. È forse il meccanismo “meno problematico”. L’Io vuole “prendere le distanze” da quel che è conflittuale. Può essere anche conscio: io decido consapevolmente di isolarmi. È strettamente associato alla capacità di concentrarsi su un tema: io mi concentro nello studio proprio perché voglio “circoscrivere” ed isolare quel contenuto. Si manifesta anche, per esempio, con l’interruzione del filo del discorso, la pausa, le formule e i rituali che mirano a separare un certo atto da quelli che lo precedono e lo seguono.
2.1.6.9. NEGAZIONE
2.1.6.9.1. Noi percepiamo che vi è un qualcosa che “bussa”, che sta per emergere alla coscienza e che potrebbe causarci dispiacere; questo contenuto oltrepassa la censura e, di conseguenza - per difenderci - rifiutiamo che ci appartenga. La negazione è il procedimento con cui il soggetto, pur formulando un proprio desiderio, pensiero, sentimento, sino a quel momento rimosso, continua a difendersene negando che gli appartenga. Opera quando la rimozione fallisce per cui il contenuto rimosso emerge alla coscienza, ma l’individuo erige una seconda barriera difensiva; alla negazione tendono ad opporsi la percezione e la memoria. Nell’adulto questo meccanismo è spesso patologico, perché risulta compromesso l’esame di realtà (a meno che non sia transitorio e momentaneo). La negazione, attraverso la parola, consente di negare la realtà trasformandola nel suo contrario.
2.1.6.10. ANNULLAMENTO RETROATTIVO
2.1.6.10.1. L’annullamento retroattivo è il meccanismo di difesa con cui il soggetto si sforza di fare in modo che pensieri, parole o atti appartenenti al passato non siano avvenuti utilizzando a tal fine un pensiero, una parola, un atto di significato opposto. In questo meccanismo di difesa si distinguono due momenti. Nel primo momento prevale un tipo di pulsione, nel secondo domina quella opposta. L’Io si allea con una pulsione opposta, a quella, cioè, legata alla rappresentazione da cui si difende. Gli atti di espiazione e di riparazione sono tipici dell’annullamento retroattivo (es. per ripristinare la propria integrità morale, si decide di prendere i voti). In sintesi: metto in atto un comportamento opposto a ciò che ho fatto in passato con l’obiettivo di far riappacificare l’Es con il Super-io - esempio - in passato ho girato film hard di cui adesso mi vergogno; con il tentativo di “riparare” questa cosa, decido di “annullare il passato” ed entro in un convento o divento devoto ad un Santo.
2.1.6.11. CONVERSIONE NELL'OPPOSTO
2.1.6.11.1. È il processo mediante il quale la meta pulsionale si trasforma nel suo opposto, passando dall’attività alla passività e viceversa. In sintesi: il soggetto che nel corso della vita ha vissuto una situazione di aggressione e, di conseguenza, ha rappresentato per un certo periodo il ruolo della vittima, per superare e reagire a questa “situazione” si identifica con colui che lo aggredisce e quindi si pone come “aggressore” nei confronti di un altro oggetto esterno.
2.1.6.12. RAZIONALIZZAZIONE
2.1.6.12.1. Rendere lecito, l’illecito” La razionalizzazione è il procedimento con cui il soggetto cerca di dare una spiegazione coerente, dal punto di vista logico o accettabile dal punto di vista morale, per giustificare una condotta, un’idea, un sentimento, che - a livello inconscio - ha invece motivazioni inaccettabili. La sua funzione è quindi quella di “camuffare” i vari elementi del conflitto difensivo; è diversa dall’inganno e dalla menzogna, in quanto il soggetto è inconsapevole di mentire o di ingannare. L’individuo sente il bisogno di giustificare sul piano sociale la natura e la forma dei suoi desideri e di trovare ad essi una spiegazione rassicurante.
2.1.6.13. INTELLETTUALIZZAZIONE
2.1.6.13.1. L’intellettualizzazione è il processo mediante il quale il soggetto, attraverso l’attività intellettuale, controlla i contenuti affettivi ed istintuali per padroneggiare l’ansia e la tensione. L’Io vuole “dominare” i processi pulsionali, associandoli ad idee che possono essere vissute senza angoscia. Questo meccanismo di difesa viene spesso utilizzato dagli adolescenti che controllano in questo modo le sensazioni fisiche intense e i conflitti interni con speculazioni filosofiche religione.
2.1.7. SVILUPPO PSICOSESSUALE
2.1.7.1. EPIGENETICO
2.1.7.1.1. Il modello di sviluppo della libido proposto da Freud è di tipo epigenetico (vi è un’evoluzione - una fase condiziona l’altra). Freud parla di sviluppo psico-sessuale, due cose che vanno “a braccetto”. Da questo punto di vista Freud è un vero e proprio rivoluzionario perché parla per primo di fasi pre-genitali e di fasi sessuali.
2.1.7.2. FASI E ZONE EROGENE
2.1.7.2.1. DESCRIZIONE ELEMENTI
2.1.7.2.2. ZONA E FASE ORALE
2.1.7.2.3. ZONA E FASE ANALE
2.1.7.2.4. ZONA E FASE FALLICA EDIPICA
2.1.7.2.5. FASE DI LATENZA
2.1.7.2.6. FASE GENITALE
2.1.8. NARCICISMO
2.1.8.1. Il narcisismo è uno stadio intermedio tra l’autoerotismo e l’allo-erotismo*, in cui il bambino investe tutta la libido su sé stesso prima di rivolgerla agli oggetti esterni.
2.1.8.2. NARCICISMO PRIMARIO
2.1.8.2.1. narcisismo primario: l’appagamento è esclusivamente autoerotico; nel narcisismo primario non vi è ancora l’altro, vi è solo (ancora) l’esperienza che possono procurarmi con il mio corpo (per questo Freud dice che è antecedente alla costruzione dell’Io)
2.1.8.3. NARCICISMO SECONDARIO
2.1.8.3.1. narcisismo secondario: l’appagamento viene rivolto verso l’esterno. Qui subentra il concetto di identificazione (capta qualcosa dall’altro e lo fa suo, lo assimila - quindi il narcisismo secondario è una tappa importantissima che definisce l’identità di una persona). Freud definisce il narcisismo secondario come un tentativo di ricostruire delle condizioni interiori, psichiche, di piacevolezza e di autoconservazione (quello che prima potevo esperire da solo, adesso mi serve l’altro, l’oggetto, la relazione oggettuale).
2.1.9. COMPLESSO DI EDIPO
2.1.9.1. ’insieme organizzato dei desideri amorosi e ostili che il bambino prova nei confronti dei suoi genitori.
2.1.9.1.1. FORMA POSITIVA
2.1.9.1.2. FORMA NEGATIVA
2.1.9.1.3. FORMA COMPLETA
2.1.9.2. IMPORTANZA E FUNZIONE
2.1.9.2.1. Freud cerca di dare una spiegazione culturale e sociale dell’incesto (Totem e tabù, 1913). L’Edipo c’è sempre stato in tutte le culture e in tutte le popolazioni! Il complesso di Edipo, dunque, presuppone una rinuncia: nel caso specifico del maschio dell’oggetto materno e della femmina di quello paterno (quindi: interiorizzare i “NO”, le leggi, le norme e le regole). → Quale funzione ha il complesso di Edipo? La principale funzione del complesso di Edipo è quella del superamento della tentazione a trasgredire (inconscia) e quindi dell’interiorizzazione dei “no”, delle regole e delle norme
2.1.10. PSICOPATOLOGIA
2.1.10.1. PSICOPATOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA
2.1.10.1.1. Freud si focalizza sulla lotta continua fra l’Io e l’Es (conflitto che caratterizza ciascuno di noi durante la nostra quotidianità). Questo conflitto si placa quando l’energia che l’Io ha a disposizione prevale su quella dell’Es (L’Io dice: Es, ti senso, ma comunque riesco a fronteggiarti - qui subentrano i meccanismi di difesa). Quando però i meccanismi di difesa falliscono e vacillano, perché l’Es è troppo forte e s’impone sull’Io, subentrano gli atti sintomatici e i sintomi.
2.1.10.1.2. ATTI SINTOMATICI
2.1.10.1.3. MOTTO DI SPIRITO
2.1.10.1.4. COAZIONE
2.1.10.2. IL SINTOMO
2.1.10.2.1. Il passaggio da una situazione conflittuale ad un “conflitto vero e proprio” (produzione di sintomi), si ha quando la rappresentazione pulsionale intollerata assume maggiore intensità ed esercita una pressione eccessiva contro la barriera censoria; oppure quando l’Io si sente indebolito e fragile, non in grado di fronteggiare la pressione stessa. I sintomi si rendono manifesti quando vi è un conflitto fra l’Io (inconscio) e l’Es. Che cos’è, nel dettaglio, il sintomo? • È un fenomeno soggettivo da decodificare avvertito dal paziente; • è il risultato (parzialmente riuscito) dell’Io di far fronte alle esigenze dell’Es; • è una formazione di compromesso (fra il contenuto dell’Es che tende ad emergere e le contro- cariche dell’Io che ostacolano tale processo); • è una formazione reattiva (permette di “dominare” un impulso inaccettabile, l’Io mette in atto meccanismi di difesa potenti che presentano una tendenza opposta rispetto a quella dell’impulso inaccettabile); • è una formazione sostitutiva (permette di soddisfare un desiderio rimosso tramite un altro desiderio). Il sintomo fa riferimento ai concetti di fissazione e di regressione. Affinché un sintomo sia patologico è necessaria la presenza di due fattori: • quantitativo: riguarda la quantità di energia pulsionale che entra in gioco nella regressione; essa viene sottratta ad investimenti maturi e rinforza punti di fissazione; • qualitativo: riguarda il tipo di conflitto che si è in origine sviluppato al punto di fissazione, cioè il tipo di difese utilizzate nel conflitto infantile ora attivate dalla regressione.
2.1.11. SOGNI
2.1.11.1. DOMANDA A SCELTA
2.1.11.1.1. I SOGNI SECONDO FREUD
2.1.12. TRANFERT
2.1.12.1. Il transfert, inevitabilmente, si fonda sulla simmetria tra la posizione del paziente e quella del terapeuta. Sulla base di questa simmetria si istituisce quello che potremmo considerare come il “potere dell’analista”. Nella storia della psicoanalisi l’individuazione del concetto di transfert avviene relativamente tardi, a posteriori, quando Freud si ferma per riflettere sui risultati ottenuti dalla cura del suo celebre caso (Dora). La giovane paziente isterica piantò in asso un processo di cura che comunque gli aveva sino ad allora portato numerosi benefici sul piano della guarigione sintomatica. Dora metterà in atto due tipi di transfert, uno negativo ed uno positivo (in quello positivo, per esempio, Dora si rapporterà a Freud come se fosse suo padre). Il termine transfert compare per la prima volta, ben prima del caso di Dora, in un passo de “L’interpretazione dei sogni” del 1899: Appunti a cura di Simone Quagliata 25 “La rappresentazione inconscia è, in quanto tale, generalmente incapace di penetrare nel preconscio e vi manifesta un effetto soltanto unendosi a una rappresentazione innocente che fa parte del preconscio trasferendo su di essa la sua intensità e servendosene come di una copertura”
2.1.13. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.2. ANNA FREUD
2.2.1. INTRODUZIONE
2.2.2. L'IO
2.2.2.1. L'IO SECONDO SIGMUND
2.2.2.1.1. Vi è una tensione accumulata (segnale d’angoscia), l’Io consente l’eliminazione della tensione attraverso una scarica ↓ funzione adattiva + L’Io attua dei meccanismi di difesa
2.2.2.2. L'IO SUCCESSIVAMENTE
2.2.2.2.1. L’Io è un qualcosa di più, si arricchisce di “sfumature” e di precise caratteristiche: diventa il protagonista assoluto. Anna Freud, sostiene che è necessario fare attenzione alle misure difensive che l’Io mette in atto per proteggersi dall’angoscia
2.2.2.3. L'IO SECONDO ANNA FREUD
2.2.2.3.1. Anna Freud appone moltissima importanza all’Io (perché si deve relazionare al mondo reale, con il Super Io e con l’Es). Quindi, a differenza di suo padre, lei non voleva focalizzarsi sulla funzione dell’Io rispetto all’Es, ma sulla funzione dell’Io come organizzatore rispetto alle richieste che provengono da più parti. Obiettivo del lavoro terapeutico di Anna Freud è quello di rinforzare l’Io (se il soggetto ha un Io debole, fragile e poco strutturato, non riuscirà a mettere in atto tutte le sue “normali” funzioni).
2.2.2.3.2. I contenuti dell’Es possono essere conosciuti solamente se si studia l’Io; Come si comporta l’Io? Come sono le sue funzioni? (ovvero i derivati dell’Io). • Se Io ed Es sono in armonia: la scarica, il soddisfacimento e la gratificazione non richiede la partecipazione difensiva dell’Io - il bisogno viene immediatamente soddisfatto (esempio di Io ed Es in armonia → il bambino ha fame e ha a disposizione il seno materno); • Se Io ed Es non sono in armonia: nascono i conflitti e l’io mette in atto i meccanismi di difesa; se la tensione e la conflittualità aumentano, cioè se falliscono i meccanismi di difesa, vengono fuori i sintomi (Anna Freud, infatti, parla del sintomo come di una “rappresentazione di un Io zoppicante, che in quel momento non ce l’ha fatta).
2.2.3. I MECCANISMI DI DIFESA
2.2.3.1. Anna Freud fu molto criticata dai “freudiani ortodossi”: per loro la “psicoanalisi” era “inconscio” (qualcosa di sommerso e profondo); grazie a lei, invece, la “psicoanalisi” poteva anche occuparsi di ciò che era in superficie, dell’Io. “Ogni qual volta l’interesse si trasferiva da un livello più profondo ad uno più superficiale, dall’Es all’Io, si correva il rischio di essere accusati di apostasia nei confronti della psicoanalisi”. Per Anna Freud i meccanismi di difesa sono utilizzati dall’Io per combattere e fronteggiare le rappresentazioni degli istinti e degli effetti che provengono dall’Es e che, inevitabilmente, coinvolgono l’io e il Super Io. Noi non decidiamo consapevolmente di mettere in atto i meccanismi di difesa, semplicemente avvengono, sono per la maggior parte inconsci (afferiscono alla parte inconscia dell’Io).
2.2.3.2. RIMOZIONE
2.2.3.2.1. (come il padre)
2.2.3.3. SUBLIMINAZIONE
2.2.3.3.1. Spostamento degli scopi dell’istinto pulsionale verso valori socialmente più accettabili (presuppone l’accettazione o perlomeno la conoscenza di tali valori, l’esistenza cioè del Super Io). Non vi può essere sublimazione se prima non si è “creato” il Super Io.
2.2.3.4. NEGAZIONE
2.2.3.4.1. Capacità dell’Io di liberarsi di fatti spiacevoli (come mi libero da questo problema? Ne nego l’esistenza). Vi è una lieve differenza fra la negazione di Freud e quello della figlia: • Anna: l’Io vuole fuggire dall’angoscia rinunciando al desiderio al fine di evitare che siano ricollegabili alla propria persona; • Sigmund: è più presente la questione del “ci sono, ma non mi appartengono”
2.2.3.5. FORMAZIONE REATTIVA
2.2.3.5.1. Negazione della realtà e capovolgimento dei fatti reali nel loro contrario, per mezzo delle fantasie dell’Io. Anna Freud pone l’accento sulla “drammatizzazione” (il comportamento che mettiamo in atto è esattamente l’opposto - drammatizzato - al desiderio inconscio intollerabile).
2.2.3.6. LIMITAZIONE DELL'IO
2.2.3.6.1. Permette di allontanare le sensazioni spiacevoli attuali provenienti dall’esterno perché potrebbero far sorgere delle sensazioni simili vissute nel passato (la realtà “riattiva” sensazioni già vissute nel passato).
2.2.3.7. INTROIEZIONE
2.2.3.7.1. → è un meccanismo di difesa “ideato” da Anna, anche se il padre lo dava un po’ per scontato - Sigmund parlava di interiorizzazione) Consiste nell’introiettare alcuni aspetti di un oggetto ansiogeno e disturbante assimilando così un’esperienza angosciante appena provata (introiettando quell’oggetto, che mi dà ansia, io lo posso gestire e controllare - così come posso gestire l’ansia). La questione dell’oggetto angosciante e ansiogeno è un concetto “nato” da Anna Freud che poi, successivamente, sarà ripreso anche da altri autori. Questo meccanismo di difesa è strettamente associato a un altro importante meccanismo: l’identificazione con l’aggressore ( → assumendo il ruolo dell’aggressore e i suoi attributi o imitando la sua aggressione, l’Io si trasforma da “minacciato” a “minacciatore”).
2.2.3.8. PROIEZIONE
2.2.3.8.1. PROIEZIONE Consiste nell’attribuire agli altri desideri, tendenze, rappresentazioni che non si vuole riconoscere come proprie. Vi è una notevole differenza fra la proiezione di Sigmund e quella di Anna: • Sigmund: è un meccanismo arcaico (attribuisco agli altri desideri e tendenze che non voglio riconoscere come miei); • Anna: non è un meccanismo così tanto arcaico, perché vi deve essere la partecipazione anche dell’Io e del Super Io (presuppone un sottoporsi alla critica altrui, poi un’interiorizzazione di questa critica e successivamente una gestione - in maniera appropriata - degli impulsi attribuiti; e un modo per gestire questi impulsi è quello di attribuirli agli altri*)
2.2.3.9. IDENTIFICAZIONE CON L'AGGRESSORE
2.2.3.9.1. (→ corrisponde alla conversione nell’opposto del padre Sigmund) L’identificazione con l’aggressore consiste nell’assumere il ruolo dell’aggressore o imitare la sua aggressione. L’Io, in sostanza, si trasforma da “minacciato” a “minacciante”. In questo meccanismo di difesa vi è un passaggio comportamentale da un ruolo passivo a un ruolo attivo che, in qualche modo, richiama il fenomeno della proiezione. Questo avviene quando l’Io introietta l’autorità e la critica e la incorpora nel Super Io (proiezione perché il soggetto proietta aspetti “proibiti” e aggressivi che riguardano l’altro). Il meccanismo di difesa ha l’obiettivo di gestire e monitorare gli aspetti aggressivi che provengono dall’altro. L’identificazione con l’aggressore diventa patologico allorché viene coinvolto nella vita amorosa attuale.
2.2.3.10. RINUNCIA ALTRUISTICA
2.2.3.10.1. La rinuncia altruistica consiste nell’interessarsi in maniera affabile e amichevole alla soddisfazione degli istinti degli altri gratificando indirettamente i propri, nonostante la proiezione del Super Io. Questo meccanismo nasce quando la proiezione permette di stabilire dei legami positivi, validi.
2.2.3.11. ASCETISMO
2.2.3.11.1. L’ascetismo consiste nella preoccupazione, non tanto della gratificazione o della frustrazione di determinati desideri istintuali, quanto della gratificazione o della frustrazione istintuale di per se stessa (rimandare). Con questo meccanismo di difesa il soggetto vuole rimandare tutto ciò che è inerente al godimento e al soddisfacimento. È tipico degli adolescenti i quali, spesso, si sentono “assaliti” da un certo grado di godimento e pulsione di cui non sanno bene spiegare l’entità. Per maneggiare questa “carica” decidono di rinunciarci (oppure rimandano, posticipano la gratificazione). “È un po’ come se l’adolescente si collocasse all’interno di una “bolla” per non esperire e non maneggiare la carica pulsionale” (vuole rimandare il soddisfacimento della carica pulsionale oppure vi rinuncia fin da subito). Questa “sfiducia” nell’adolescente nei confronti dell’istinto costituisce una tendenza pericolosa per il futuro (il continuare a “rimandare” senza voler raggiungere la scarica pulsionale, con il tempo, può essere pericoloso e dare vita al conflitto e alla psicopatologia).
2.2.3.12. INTELLETTUALIZZAZIONE
2.2.3.12.1. L’intellettualizzazione consiste nell’alimentare i sogni ad “occhi aperti” dell’adolescente; Anche questo meccanismo di difesa viene collocato soprattutto nell’adolescenza. Tutte le attività intellettuali messe ad opera dell’adolescente (meditare, leggere ecc.) gli procurano soddisfazione. Anna Freud, a proposito di questo meccanismo di difesa, ci parla di “intellettualizzazione della vita istintuale” in quanto vi è da parte del soggetto un tentativo di dominare i processi istintuali che, in questo caso, vengono “maneggiati” attraverso il pensiero intellettualizzato.
2.2.4. INFLUENZA DELLA REALTÀ GENITORIALE E DELL'AMBIENTE
2.2.4.1. Ciò su cui si focalizza maggiormente Anna Freud, a differenza del padre, è la questione dell’ambiente: vi sono dei fattori esterni che possono impattare ed influenzare il normale sviluppo del bambino. Noi nasciamo, sosteneva Anna, con un “bagaglio genetico” (predisposizioni innate), ma questo “bagaglio” troverà sempre un continuo confronto con le richieste e le influenze ambientali e con la vulnerabilità individuale (atteggiamenti interiorizzati acquisiti). Anna Freud, quindi, ci parla anche di vulnerabilità (ovvero di atteggiamenti interiorizzati acquisiti)
2.2.5. GLI 8 MOMENTI EVOLUTIVI
2.2.5.1. Anna Freud tenterà un’evoluzione delle fasi di sviluppo psicosessuale del padre, individuando otto momenti evolutivi. La sua nuova “interpretazione” includerà, rispetto alle fasi descritte dal padre, l’influenza dell’ambiente.
2.2.5.2. UNITÀ BIOLOGICA MADRE-NEONATO (NARCISISMO)
2.2.5.2.1. Madre e bambino sono un “tutt’uno” (la madre assiste e cerca di andare incontro al soddisfacimento dei bisogni del neonato e il neonato fa la stessa cosa con la madre). È come se uno fosse il “prolungamento” dell’altro (il neonato ancora non sa cosa voglia dire “essere altro da sè”)
2.2.5.3. RAPPORTO CON L'OGGETTO PARZIALE
2.2.5.3.1. In questa fase il bambino investe e disinveste con riferimento alla soddisfazione dei propri bisogni (se l’oggetto procura soddisfacimento al neonato, quell’oggetto sarà da parte sua “buono” e positivo)
2.2.5.4. COSTANZA DELL'OGGETTO
2.2.5.4.1. Anche se non vi è più la soddisfazione del bisogno, il bambino mantiene la rappresentazione e l’immagine dell’oggetto.
2.2.5.5. RAPPORTO AMBIVALENTE IN FASE SADICO-ANALE
2.2.5.5.1. L’Io si “aggancia” a tutti gli oggetti d’amore e, contemporaneamente, tende a rifiutarli e torturarli (questo accade quando si cerca di controllare l’azione su quel determinato oggetto).
2.2.5.6. FASE FALLICO-EDIPICA
2.2.5.6.1. Il bambino è dominato da desideri di stoffa “edipica”.
2.2.5.7. PERIODO DI LATENZA
2.2.5.7.1. La tensione pulsionale è “affievolita”, avviene la sostituzione delle figure genitoriali con i pari e i coetanei.
2.2.5.8. PRE-ADOLESCENZA
2.2.5.8.1. Si riattivano componenti delle fasi precedenti.
2.2.5.9. ADOLESCENZA
2.2.5.9.1. È un momento particolare e difficile per il ragazzo, definito dalla stessa Anna come “battaglia adolescenziale”. L’adolescente tenta di emanciparsi dal legame con i genitori per stabilire delle nuove pulsioni libidiche.
2.2.6. DALLA DIPENDENZA MATERNA ALL'AUTONOMIA
2.2.6.1. EGIOCENTRISMO--->SOCIEVOLEZZA
2.2.6.2. GIOCO AUTOEROTICO--->UTILIZZO DEI GIOCATTOLI
2.2.6.3. ALLATTAMENTO---> ALIMENTAZIONE ADULTA
2.2.6.4. INCONTINENZA---> CONTROLLO DEGLI SFINTERI
2.2.6.5. IRRESPONABILITÀ---> RESPONSABILITÀ
2.2.7. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.3. SPITZ
2.3.1. INTRODUZIONE
2.3.2. DEPRESSIONE ANACLITICA
2.3.2.1. Riguarda i bambini che sono stati separati dalla madre tra il 6° e l’8° mese di vita. Si esprime attraverso i seguenti sintomi: • il bambino diventa piagnucoloso e ha la tendenza ad aggrapparsi; • dopo ca. 1 mese: i pianti si trasformano in gemiti lamentosi, comincia a perdere peso e lo sviluppo si arresta; • dopo ca. 2 mesi: rifiuta il contatto, rimane sdraiato a faccia in giù nella culla, non dorme più, tende a contrarre malattie, mostra rigidità facciale e ritardo motorio. Spitz sosteneva che la depressione anaclitica era una condizione reversibile: la separazione può essere “rimediata” se non si prolunga oltre i 3-5 mesi.
2.3.3. SINDROME DA OSPEDALIZZAZIONE
2.3.3.1. Insorge nei bambini che non hanno mai goduto della madre inseriti nei primi 18 mesi di vita in ospedale o in istituto in condizioni di totale deprivazione affettiva. La sindrome da ospedalizzazione può manifestarsi nei seguenti modi: • grave ritardo dello sviluppo psicomotorio; • ritardo nella crescita; • ritardo della manipolazione, dell’esplorazione, del linguaggio (linguaggio rudimentale), della percezione affettiva e dell’esplorazione dell’ambiente. Critica a Spitz: si è focalizzato solo o quasi del tutto sulla figura della madre (attenzione, l’ambiente non è costituito solo dalla figura materna).
2.3.4. PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO
2.3.4.1. Spitz sosteneva che il primo anno di vita del bambino era fondamentale per la sua crescita e per il suo sviluppo. Cosa avviene in questo primo anno di vita del bambino? Vi è, secondo Spitz, un “periodo neonatale” caratterizzato da una “non differenziazione” (il bambino è “fuso” con la madre, sono un’unica entità). Le esperienze del bambino, in questa fase – cioè nei primi 3 mesi, sono di esclusivo ordine affettivo e la figura materna rappresenta il primo promotore di un’ambiente esterno facilitante il suo sano sviluppo. I processi affettivi fra madre e bambino, in sostanza, rappresentano delle vere e proprie “fondamenta” da cui dipenderà il futuro psicologico del bambino (l’affetto gioca il ruolo più importante). La libido, secondo Spitz, ha un ruolo importante per organizzare le funzioni dell’Io.
2.3.5. ORGANIZZATORI E INDICATORI PSICHICI
2.3.5.1. Gli organizzatori psichici rappresentano dei “punti di svolta” evolutivi critici. Attraverso queste fasi, si costituisce la relazione oggettuale e il raggiungimento di un nuovo livello di relazione oggettuale. Spitz descrive 3 tipi di organizzatori psichici, gli indicatori, invece, sono quei comportamenti osservabili che segnalano l’avvenuto progresso evolutivo.
2.3.5.1.1. STADIO PRE OGGETTUALE
2.3.5.1.2. OGGETTO PRECURSORE
2.3.5.1.3. OGGETTO PROPRIAMENTE DETTO
2.3.6. MALATTIE PSICOGENETICHE DELL'INFANZIA
2.3.6.1. L’organizzazione psichica del bambino si organizza mediante il rapporto madre-bambino. Se questo non avviene, siamo di fronte a quelle che Spitz definiva come malattie psicotossiche. La madre agisce come una sorta di “agente patogeno”, come una tossina psicologica. Le malattie psicotossiche sono l’espressione di una madre assolutamente disfunzionale (troppa presenza, troppa assenza, rifiuto, iperpermessività ecc.). In sostanza, sosteneva Spitz: se il bambino sta male e ha dei disturbi è da attribuire alla madre.
2.3.7. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.4. MAHLER
2.4.1. INTRODUZIONE
2.4.2. PERSCORSO EVOLUTIVO INTRAPSICHICO DEL BAMBINO
2.4.2.1. FASE AUTISTICA NORMALE
2.4.2.1.1. Il bambino è un “puro organismo biologico”, dominano i processi fisiologici (è come se il bambino vivesse ancora nell’ambiente intrauterino e si ritrova, nel giro di pochissimo, in un ambiente completamente diverso).
2.4.2.2. FASE SIMBIONTICA NORMALE
2.4.2.2.1. Il bambino riesce a recepire, sebbene in modo ancora poco chiaro e “ovattato”, gli stimoli dell’esterno. Comincia pian piano a distinguersi dall’oggetto.
2.4.2.3. SEPARAZIONE INDIVIDUAZIONE
2.4.2.3.1. Separazione: è il primo distacco e il primo processo di differenziazione e “sganciamento” dalla figura materna; è il superamento dalla figura “simbiotica”. Individuazione: è la conquista dell’autonomia (autonomie intrapsichiche); sono consapevole di avere caratteristiche uniche, diverse da quelle degli altri. Secondo la Mahler, la fase di “separazione-individuazione”, si suddivide in ulteriori sotto-fasi.
2.4.3. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.5. KLEIN
2.5.1. INTRODUZIONE
2.5.1.1. PUNTI CHIAVE
2.5.1.1.1. IO RUDIMENTALE SIN DALLA NASCITA
2.5.1.1.2. SENTIMENTI DI AMORE E PERSECUZIONE VERSO LA MADRE
2.5.1.1.3. SVILUPPO TRAMITE FATTORI INTERNI E ESTERNI
2.5.1.1.4. MECCANISMI DI DIFESA CONTRO L'ANGOSCIA (SCISSIONE E PROIEZIONE)
2.5.1.1.5. LE FANTASIE INCOSCE INFLUENZANO L'ESPERIENZA DELLA REALTÀ ESTERNA
2.5.1.1.6. DA OGGETTI PARZIALI (SENO BUONO E SENO CATTIVO) A OGGETTI INTERI
2.5.2. CONFRONTO CON FREUD
2.5.2.1. IN GENERALE
2.5.2.1.1. Per la teoria pulsionale di Freud la capacità di entrare a contatto con gli oggetti compare solo a un certo punto dello sviluppo ---------------------------- Per la teoria delle relazioni oggettuali di Melanie Klein il neonato è impiegato fin dai primi mesi di vita nello sforzo di relazionarsi con gli oggetti intorno a sé e con la madre
2.5.2.2. ANGOSCIA
2.5.2.2.1. L’angoscia proviene da una rimozione non riuscita --------------------------- L’angoscia è dovuta a un istinto di vita e a un istinto di morte ↓ realtà che dà benessere (seno “buono”) VS realtà cattiva (seno “cattivo”) L’istinto di vita e di morte sono oggetto di proiezione verso l’esterno
2.5.2.3. PULSIONI
2.5.2.3.1. Le pulsioni hanno un fondamento biologico (corporeo), creano cioè una tensione che l’apparato psichico (non l’Io) cerca di eliminare ----------------------------- Le pulsioni sono fenomeni psicologici: il corpo è semplicemente un “mezzo” attraverso cui si manifestano Per la Klein le pulsioni appaiono indissolubilmente legate all’oggetto (non c’è pulsione senza oggetto e viceversa)
2.5.2.4. PSICOSI
2.5.2.4.1. Le psicosi sono inaccessibili alla psicanalisi -------------------------------- Estensione alla psicosi adulta
2.5.2.5. FASI/POSIZIONI
2.5.2.5.1. Freud parla di “fasi” evolutive che devono essere attraversate e superate ----------------------------------- Klein parla di “posizioni” cioè di organizzazioni universali dell’esperienza che rimangono attive per tutto il corso della vita. Sono una costellazione di angosce e difese che organizzano l’esperienza individuale. Le posizioni non sono fasi di passaggio: caratterizzano l’infanzia, ma si ripropongono per tutta la vita
2.5.2.6. COMPLESSO DI EDIPO
2.5.2.6.1. Per Melanie Klein lo scaturire dei meccanismi edipici nei bambini ha una datazione molto precoce rispetto a quanto pensava Sigmund Freud (si sviluppa già nel primo/secondo anno come conseguenza alla frustrazione dello svezzamento e dell’educazione alla pulizia). Secondo Klein questi stadi edipici iniziano ad influenzare la psiche del bambino già nella fase pregenitale tanto che i conflitti che ne scaturiscono riescono ad oscurare la fase tipicamente genitale che si evidenzia solo verso il terzo e il quinto anno d’età. Ciò che a quella età è evidente, sempre secondo la Klein, è l’avvenuta maturazione del complesso edipico e lo sviluppo del Super-io
2.5.2.7. SUPER IO
2.5.2.7.1. Per Melanie Klein il Super Io si sviluppa precocemente già entro il primo anno di vita anticipando la comparsa del c. d’Edipo
2.5.2.8. IO
2.5.2.8.1. Per la Klein l’Io è presente fin dalla nascita
2.5.3. LA TEORIA DELLO SVILUPPO
2.5.3.1. PROCESSI DIFENSIVI CHE OPERANO IN COLLEGAMENTO FIN DALLA NASCITA
2.5.3.1.1. SCISSIONE
2.5.3.1.2. PROIEZIONE
2.5.3.1.3. INTROIEZIONE
2.5.3.1.4. IDEALIZZAZIONE
2.5.3.1.5. DINIEGO
2.5.3.1.6. IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA
2.5.3.2. POSIZIONE SCHIZOPARANOIDE (0-3 MESI DI VITA)
2.5.3.2.1. scissione dell’oggetto (buono vs cattivo), presenza di pulsioni opposte (libidiche/aggressive) Inizialmente il seno materno, nelle fantasie precoci del bambino, viene scisso in buono e in cattivo. In questa condizione, in virtù del meccanismo della SCISSIONE, vi è la suddivisione netta in parti buone e in parti cattive dell’Io del bambino. Successivamente, il seno buono e quello cattivo, vengono proiettati e poi introiettati divenendo in virtù di tali meccanismi parti buone e parti cattive dello stesso oggetto. L’angoscia che prova il bambino è dovuta all’istinto di morte.
2.5.3.2.2. Perché questa posizione si chiama “schizo-paranoide”? “Schizo” → è riferito alla schizofrenia (il soggetto schizofrenico usa il meccanismo della scissione per distinguere tra oggetto buono e oggetto cattivo). “Paranoide” → perché è riferito alla proiezione dell’istinto di vita (seno “buono”) e dell’istinto di morte (seno “cattivo”) seguita da introiezione.
2.5.3.3. POSIZIONE DEPRESSIVA (DAI 4 MESI)
2.5.3.3.1. oggetto interno, non più scisso (la madre non è più un “seno”, ma una persona intera)
2.5.3.3.2. AMBIVALENZA
2.5.3.3.3. DIFESE MANIACALI
2.5.3.3.4. FALLIMENTO DELL’ELABORAZIONE DEL LUTTO E DELLA RIPARAZIONE DURANTE LA POSIZIONE DEPRESSIVA
2.5.3.4. RAPPRESENTAZIONE DELL'OGGETTO
2.5.3.4.1. OGGETTO PARZIALE
2.5.3.4.2. OGGETTO INTERO
2.5.3.4.3. FALLIMENTO DEL PASSAGGIO DA OGGETTO PARZIALE A OGGETTO TOTALE
2.5.3.4.4. FANTASIE INCONSCE
2.5.3.5. DIFESE PRIMITIVE
2.5.3.5.1. INTROIEZIONE
2.5.3.5.2. SCISSIONE
2.5.3.5.3. PROIEZIONE
2.5.3.5.4. IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA
2.5.3.5.5. IDEALIZZAZIONE
2.5.3.6. DIFFERENZA FRA LE DUE POSIZIONI
2.5.3.6.1. POSIZIONE SCHIZO-PARANOIDE
2.5.3.6.2. POSIZIONE DEPRESSIVA
2.5.4. IL RUOLO DEL GIOCO
2.5.4.1. Per Melanie Klein il gioco rappresenta l’espressione simbolica delle fantasie e dei desideri inconsci dei bambini. Si tratta dunque di una modalità di esplorazione dell’inconscio del bambino, al pari dei sogni (→ basato sugli stessi meccanismi e che può essere interpretato allo stesso modo). Per la Klein il gioco è lo strumento “principe” della psicanalisi infantile, dal momento che con loro non possono essere utilizzate le libere associazioni. Il colpo di genio della Klein fu proprio quello di utilizzare il gioco del bambino al pari del discorso dell’adulto in analisi, in particolare al pari della narrazione di un sogno. Melanie Klein non fu la prima a utilizzare il gioco in seduta, ma fu la prima a intenderlo come diretta e immediata espressione dei processi inconsci. Cosa intende Melanie Klein per “equazione simbolica”? Equazione simbolica = meccanismo per il quale le figure dei genitori, dei fratelli o di parti proprie del corpo o dei genitori vengono identificate con altri oggetti o funzioni del mondo esterno. In ogni sorta di attività ludica (di gioco) vi è sempre un investimento libidico (es. palla, cerchio o altri giochi sono equiparati, per analogia o forma, a organi genitali).
2.5.5. DISPUTA TRA ANNA FREUD E KLEIN
2.5.5.1. Melanie Klein e Anna Freud si occuparono entrambe di analisi infantile. Anna Freud riteneva che la Klein si era troppo distaccata dal modello teorico del padre Sigmund Freud. All’interno della società psicanalitica inglese le differenze teorico-cliniche tra le due studiose generarono una “scissione”
2.5.5.2. GIOCO
2.5.5.2.1. ANNA il gioco è la ripetizione di esperienze dolorose che permette al bambino di dominarle e di elaborarle (coazione a ripetere) → anche Sigmund Freud la pensava in questo modo. ----------------------------- KLEIN = il gioco è il modo che il bambino utilizza per esprimersi (è inutile fare con i bambini le associazioni libere). La Klein lasciava giocare i bambini liberamente, senza intervenire.
2.5.5.3. TRANSFERT
2.5.5.3.1. ANNA Non esiste perché il bambino non ha ancora interiorizzato le figure genitoriali. ------------------------ KLEIN Esiste anche nel bambino molto piccolo.
2.5.5.4. CONFLITTO NEVROTICO (EDIPO)
2.5.5.4.1. ANNA Il conflitto nevrotico si forma al culmine della vita sessuale infantile attraverso il complesso di Edipo (5-6 anni). --------------------------- KLEIN Il conflitto nevrotico avviene sin da subito, in tenerissima età.
2.5.5.5. CON COSA È IN LOTTA L'UOMO?
2.5.5.5.1. ANNA Ciascuno di noi lotta contro desideri bestiali, timori di punizione e sensi di colpa. KLEIN Ciascuno di noi lotta contro profondi terrori di annichilimento (angoscia paranoide) e di abbandono assoluto (angoscia depressiva).
2.5.6. AGGRESSIVITÀ INVIDIA E GRATITUDINE
2.5.6.1. AGGRESSIVITÀ
2.5.6.1.1. Per Melanie Klein, l’aggressività dell’individuo, è un fattore costituzionale: la maggior parte di noi utilizza l’aggressività nei confronti degli oggetti aggressivi. Esiste però una particolare forma di aggressività che, al contrario, “attacca” gli oggetti buoni. Un esempio… Il seno “buono”, che nutre con il suo latte, non è sempre disponibile. Questa “limitazione” è sentita dal bambino come intollerabile: egli, in fantasia, desidera impossessarsi di tutte le cose buone contenute nel seno, lasciandolo completamente svuotato. Il bambino prova invidia… il bambino punta al seno un vero e proprio “attacco invidioso”, con l’obiettivo di distruggerlo, impossessarsene in fantasia…non tollera che quella fonte possa rimanere esterna e dunque non sempre disponibile! In tutti i suoi lavori Melanie Klein sottolinea l’importanza fondamentale della prima relazione oggettuale del bambino (il rapporto col seno materno e la madre) e giunge alla conclusione che se questo oggetto primario, una volta introiettato, pone radici stabili nell’Io, questo crea i presupposti di base per uno sviluppo psicologico soddisfacente.
2.5.6.2. INVIDIA
2.5.6.2.1. Il bambino vuole distruggere l’oggetto, saccheggiarlo, non perché cattivo, ma perché è buono. Attraverso l’invidia il bambino distrugge gli oggetti buoni, vi è una perdita di sicurezza e un successivo aumento dell’angoscia e del terrore persecutorio. • Diretta espressione della pulsione di morte, è energia distruttiva; • è riconoscibile nella posizione schizo-paranoide; • ostilità e rancore verso chi possiede qualcosa che si desidera, ma non si riesce o non si può possedere; • si realizza nel desiderare di danneggiare l’oggetto e di privarlo di ciò che possiede.
2.5.6.3. GRATITUDINE
2.5.6.3.1. La gratitudine è necessaria per superare l’invidia. Quando l’oggetto nutre e sostiene i bisogni del bambino, il bambino prova gratitudine. Gratitudine e invidia entrano in conflitto non appena l’Io comincia a integrarsi e, se l’invidia non è dominante, la gratitudine la supera e la modifica. L’armonizzazione dei due sentimenti è alla base di un Io integrato e stabile: • se prevalgono sentimenti di amore e gratitudine → il bambino svilupperà un Io integrato ed equilibrato; • se prevalgono angosce persecutorie e invidia (se non sono controbilanciate da sentimenti positivi) → il bambino svilupperà una psicopatologia.
2.5.7. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.6. WINNICOTT
2.6.1. INTRODUZIONE
2.6.2. SVILUPPO EMOZIONALE PRIMARIO
2.6.2.1. Secondo Winnicott esiste uno sviluppo emozionale primario che và dalla nascita ai 5-6 mesi di vita, un periodo di dipendenza assoluta
2.6.2.2. INDIPENDENZA
2.6.2.2.1. evoluzione graduale: da una dipendenza assoluta a una dipendenza relativa e per ultimo all'assoluta indipendenza
2.6.2.3. INTEGRAZIONE
2.6.2.3.1. sviluppo da una non integrazione dello sviluppo psichico alla intergrazione (maggiore maturità psichica
2.6.2.4. ORGANIZZAZIONE
2.6.2.4.1. Sviluppo da una non organizzazione all’organizzazione psichica (da uno stato di “non riesco a delimitare ciò che sono io e ciò che è il mondo esterno” all’instaurarsi di una identità personale).
2.6.3. VERO SÈ FALSO SÈ
2.6.3.1. SÈ
2.6.3.1.1. È una sorta di “sotto-struttura” dell’Io (Winnicott sostiene che è una parte dell’Io). Quindi il Sé è come se fosse una funzione dell’Io che ci permette di organizzare le nostre esperienze. Tutto questo ci dà l’idea di quello che siamo e quindi una rappresentazione di noi stessi
2.6.3.2. VERO SÈ
2.6.3.2.1. (anche detto Sé centrale) Falso Sé Winnicott sostiene che il vero Sé è: “Il gesto spontaneo, l’idea personale, il sentirsi reale e creativo” Il vero Sé, in pratica, è la rappresentazione di se stessi reale, come sono io e come mi vedo io realmente (cioè l’autentica rappresentazione che io ho di me). Se io possiedo un’autentica rappresentazione di me stesso, questo mi porta ad adottare delle soluzioni e a comportarmi con gli altri in un certo modo. Il vero Sé è, secondo Winnicott, ciò su cui si deve lavorare nel percorso psicoanalitico. Cosa porta alla costruzione di un vero Sé? ↓ una madre sufficientemente buona (che con i suoi gesti e le sue cure rafforza l’Io debole e immaturo del bambino
2.6.3.3. FALSO SÈ
2.6.3.3.1. Il falso Sé può essere utile, ma chiaramente non deve prevalere per non diventare disfunzionale. La sua funzione, secondo Winnicott, è quella di costruire una “protezione” nei confronti di un ambiente che si è rilevato molte volte inadeguato. Il bambino, in sostanza, ha vissuto in un ambiente che non è stato in grado di soddisfare i suoi bisogni; egli, quindi, ha dovuto fare tutto da sé (si è dovuto adattare a un’ambiente disfunzionale). Il bambino, a livello pratico, “IMITA” gli altri (guardo la mamma e mi comporto come lei): questo genera un falso Sé. NB: vi sono aspetti anche della vita adulta in cui possiamo ritrovare un falso Sé (per esempio quando diamo precedenza all’altro, senza pensare a noi stessi). Ritroviamo molto spesso persone con un falso Sé, sono coloro che antepongono i bisogni e i desideri degli altri ai loro (questo è per loro una “protezione”). Che cosa porta alla costruzione di un falso Sé? ↓ una madre (non) sufficientemente buona (incapace di sostenere l’Io in formazione del suo piccolo) Il falso Sé, dunque, dipende dall’incapacità della madre di percepire i bisogni del figlio
2.6.4. L'IO SECONDO WINNICOTT
2.6.4.1. Egli propone l’idea di uno “stato unitario”, di un “insediamento della psiche nel soma” - e viceversa - grazie al fenomeno dell’HANDLING, cioè al modo con cui il bambino viene trattato, manipolato. Il processo si manipolazione si riferisce alla provvidenza ambientale che coincide all’incirca con l’istituzione di una relazione psicosomatica. Istruire questa dall’interno, senza una manipolazione sufficientemente attiva e responsiva, può ben costruire un compito pesante, anzi impossibile.
2.6.4.1.1. HANDLING
2.6.4.1.2. HOLDING
2.6.4.2. DIFFERENZA TRA IO E SE
2.6.4.2.1. SE
2.6.4.2.2. IO
2.6.5. LA REALTÀ E IL SENSO DI REALTÀ
2.6.5.1. ACQUISIZIONE DEL SENSO DI REALTÀ
2.6.5.1.1. Con il processo di acquisizione del senso della realtà si completano, nel pensiero di Winnicott, i processi di sviluppo (visti nell’ottica dell’evoluzione dalla dipendenza all’indipendenza). Con il senso di realtà, finalmente, il bambino acquisisce una concezione e una rappresentazione del mondo circostante. Questo processo di maturazione spinge il bambino a stabilire una relazione oggettuale, che non può consolidarsi se il mondo non gli viene offerto in modo sufficientemente buono.
2.6.5.2. DALL'ILLUSIONE AL SENSO DI REALTÀ
2.6.5.2.1. Per chiarire il passaggio dall’illusione dal senso di realtà, cioè da uno stato di essere fuso con la madre ad uno stato di essere in rapporto con la madre come qualcosa di esterno e di separato, Winnicott escogita tre tipologie di oggetti:
2.6.5.2.2. Il passaggio dallo stato di oggetto soggettivo ad una progressiva percezione dell’oggetto in quanto oggetto, procede su un ponte gettato dalla madre. La madre deve “disilludere” il bambino, deve dirgli: “guarda che l’oggetto c’era già, non sei stato tu a crearlo” (il seno non l’hai creato tu, c’era già, è una parte del mio corpo). In questo caso ritorna il concetto di individuazione: “io, bambino, sono un individuo che si distacca dall’oggetto di mia madre”.
2.6.5.2.3. Winnicott è stato uno dei primi autori a portare un po’ di positività nel funzionamento psichico, introducendo il concetto della capacità di amare (= amore come motore essenziale per un buon sviluppo psichico, amore che non è solo materno). Per Winnicott la capacità di amare consiste nella capacità di sentire un bisogno. La capacità di amare può nascere e instaurarsi solamente se si percepisce l’esigenza e il bisogno dell’altro.
2.6.6. INORGANIZZAZIONE
2.6.6.1. L’inorganizzazione presuppone una preoccupazione materna primaria.
2.6.6.1.1. La preoccupazione materna primaria è una situazione psicologica esperita dalla madre che comincia già durante la gravidanza e prosegue nelle prime settimane dopo il parto. Si tratta di uno stato psicologico di devozione, dipendenza e regressione in cui i bisogni del neonato sono avvertiti come la cosa più importante. La madre si identifica con il bambino al fine di empatizzare con i suoi bisogni. Si tratta in sostanza di uno stato di sensibilità amplificata che caratterizza la “madre sufficientemente buona”: percepire empaticamente le esigenze del neonato tramite un’identificazione proiettiva; viverle come proprie e rispondere in modo adeguato. Winnicott sottolinea che se tale stato si presentasse in altri momenti di vita corrisponderebbe a una condizione psichiatrica. “Preoccupazione” e “amore”, sostiene Winnicott, si fondono fra loro dando vita a una devozione totale da parte della madre nei confronti del bambino. La madre ritorna, quasi in maniera “primitiva”, a stati psicologici e fisici che appartengono al bambino stesso e che Winnicott chiama di “inorganizzazione” . Secondo Winnicott in questa preoccupazione materna primaria la mamma si adatta all’ambiente del bambino (quindi non è uno stato simbiotico, ma una identificazione). → È buona cosa che la madre si inorganizzi, cioè che abbandoni per un periodo il suo status di donna e di “adulta”, per immedesimarsi al meglio nel ruolo del suo bambino e capirne appieno i suoi bisogni.
2.6.7. L'OGGETTO TRANSIZIONALE
2.6.7.1. Il concetto di oggetto transizionale si riferisce alla comparsa, durante un particolare momento dello sviluppo infantile, di oggetti che assumono un significato speciale per il bambino e di cui i genitori riconoscono intuitivamente l’importanza. Donald Winnicott, che ha introdotto questo concetto in psicoanalisi, scrive che è ben noto che i bambini appena nati tendono ad usare il pugno o il pollice per stimolare la zona orale ma che poi, trascorsi alcuni mesi, tendono ad usare oggetti speciali (orsacchiotti, copertine ecc., ma anche un suono, una parola ecc.) e ad attaccarsi ad essi in modo da non poterne fare a meno. L’oggetto transizionale compare tra i 4 e i 12 mesi e la sua principale funzione è quella di calmare il bambino, in particolar modo allevia l’ansia per la separazione dalla madre e permette di rimanere per un certo tempo lontano da lei
2.6.7.1.1. L’oggetto transizionale è una “zona intermedia” tra soggetto-oggetto: “Gli oggetti transizionali rappresentano la transizione di un bambino da uno stato di essere fuso con la madre a uno stato di essere in rapporto con la madre come qualcosa di esterno e separato”.
2.6.7.2. Se la madre non c’è, il bambino può utilizzare il suo oggetto transizionale per evitare l’angoscia (anche se la letteratura ci indica che non tutti i bambini hanno un proprio oggetto transizionale). Tendenzialmente l’oggetto transizionale è solo uno (viene scelto come “sostituto della madre”), ed accompagna il bambino per un lungo periodo di tempo (può essere un peluche, una copertina e via dicendo). Winnicott attribuiva delle caratteristiche alla scelta dell’oggetto transizionale, per esempio: • non deve essere lavato; • deve essere morbido e soffice; • non deve essere freddo; • ecc. Winnicott concepisce l’oggetto transizionale non tanto come oggetto concreto quanto come possesso, come primo possesso di ciò che è “non me”, di ciò che sta fuori pur avendo ad un tempo a che fare con ciò che sta dentro.
2.6.8. OGGETTO TOSSICO
2.6.8.1. Tossico” è un qualcosa di opposto a “transizionale”. L’oggetto tossico (o “feticcio”) conduce il bambino a una condizione di perenne dipendenza.
2.6.8.1.1. OGGETTO TRANSIZIONALE VS OGGETTO TOSSICO
2.6.9. IL GIOCO
2.6.9.1. Winnicott sostiene che il gioco è soprattutto un “fare creativo”, un qualcosa in cui il soggetto sperimenta dei ruoli e delle dinamiche. Secondo Winnicott è anche importante estendere il gioco alla vita adulta. La psicoanalisi rappresenta per l’autore “l’arte del XX secolo” diretta a ripristinare la capacità di giocare: “La psicoanalisi ha luogo dove si sovrappongono due aree di gioco, quella del paziente e quella del terapeuta. La psicoterapia ha che fare con due persone che giocano insieme. Il corollario di ciò è che quando il gioco non è possibile, allora il lavoro svolto dal terapeuta ha come fine di portare il paziente da uno stato in cui non è capace di giocare a uno stato in cui ne è capace”
2.6.10. LA PSICOPATOLOGIA
2.6.10.1. Anche nella psicopatologia, Winnicott, pone l’accento sull’importanza della diade “madre-bambino”. Winnicott, nei suoi scritti, descrive - per esempio - che cos’è una madre “malata”, o una madre non sufficientemente buona. Winnicott è il primo autore che ci dice: attenzione, se la madre “non sta bene”, non va ghettizzata, ma va aiutata e supportata!
2.6.10.1.1. MADRE OGGETTO
2.6.10.1.2. MADRE AMBIENTE
2.6.10.2. APPROCCIO PSICHIATRICO
2.6.10.2.1. Si basa su una diagnosi (“etichetta”).
2.6.10.3. APPROCCIO PSICOANALITICO
2.6.10.3.1. Prende in considerazione tutta dell’individuo che, in qualche modo, esige che il soggetto parli della sua infanzia relativa alla dipendenza assoluta, relativa e all’indipendenza.
2.6.10.4. PSICOSI
2.6.10.4.1. Se il bambino, ancora nello stadio della dipendenza assoluta, va incontro a un mancato adattamento dell’ambiente ai suoi bisogni, può vivere un’angoscia catastrofica.
2.6.10.5. DISTURBI DELL'EQUILIBRIO DEL SE
2.6.10.5.1. Come abbiamo visto è grazie alla responsività della madre, cioè alla sua capacità di rispondere ai bisogni del bambino, che può istituirsi un Sé continuo nel tempo, dotato di un’esperienza psicosomatica, capace di porsi in contatto con l’Io, facilitandogli il compito di relazionarsi con gli oggetti esterni e interni.
2.6.10.6. TENDENZE ANTISOCIALI
2.6.10.6.1. Le tendenze antisociali, a differenza di quanto si potrebbe pensare, per Winnicott sono “semplicemente” una reazione, un comunicare da parte del bambino un qualcosa che non va rispetto a un vissuto interiore di deprivazione: io, bambino, ho un malessere e allora lo esprimo attraverso un comportamento non giusto, non conforme alle regole e oppositivo. È proprio per questo che, per Winnicott, la delinquenza è vista come un qualcosa che “dona speranza”*, perché, in qualche modo, si oppone a uno stato di malessere (non è un subire, ma è una reazione).
2.6.11. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.7. JUNG
2.7.1. INTRODUZIONE
2.7.2. PSICOLOGIA ANALITICA
2.7.2.1. La psicologia analitica è una scienza empiricamente fondata, pertanto comprende una teoria, un’elaborazione scritta e una ricerca accanto alla pratica psicoterapeutica. Jung capovolge finalisticamente il senso dei processi psicologici che Freud aveva interpretato deterministicamente.
2.7.2.2. si occupa di: • coscienza; • inconscio; • relazioni fra l’Io e l’inconscio.
2.7.2.3. Freud, durante l’analisi, invitava i pazienti a sdraiarsi su un lettino; entrambi non si guardavano mai in viso. Freud inoltre vedeva i suoi pazienti quattro o cinque volte alla settimana. Jung svolgeva l’analisi vis a vis coi i propri pazienti e li vedeva solo una o due volte alla settimana (questo perché dava loro il tempo di sognare).
2.7.3. I SOGNI
2.7.3.1. FINALISTICI
2.7.3.1.1. I sogni finalistici, così come suggerisce il nome, sono secondo Jung dei sogni che preparano a qualcosa. Esistono anche sogni che “preparano alla morte”. Jung li chiamava anche “sogni prospettici”. Augusto Romano, noto didatta junghiano piemontese, presentò qualche anno fa all’Ordine dei medici di Torino un insieme di sogni di pazienti in fin di vita. Un uomo, in giovane età rinomato calciatore, si trovava in sogno di fronte a un cervo. Sparò all’animale per ben tre volte, ma non riuscì mai a colpirlo. L’analista interpretò questa “impossibilità a colpire” come una non “capacità di riprendere la vita”. Poco dopo l’uomo morì. Una donna, che da lì a poco sarebbe morta, aveva sognato ella stessa a lavare in un fiume i propri indumenti intimi. Tali indumenti le sfuggivano dalle mani e venivano trasportati via dalla corrente (un po’ come gli indiani d’America che gettano nel fiume le ceneri dei propri defunti).
2.7.3.2. RICORRENTI
2.7.3.2.1. Sono sogni che si ripetono, che condividono un tema comune e che ricorrono nei mesi o negli anni (spesso sono collegati a un trauma). Spesso persone che non hanno mai fatto un’analisi hanno dei sogni ricorrenti. Al contrario, gli analisti, tendono ad averli raramente: questo perché li hanno elaborati. Quando un sogno è compreso, i simboli perdono la loro carica energetica e il sogno tende a non ripetersi.
2.7.3.3. Nell’interpretare un sogno è molto importante il suo inizio: non cogliere cosa sta dicendo il sogno all’inizio è come andare a vedere un film entrando in ritardo di venti minuti! Anche il primo sogno portato all’analista all’inizio del percorso ha una valenza importante: il primo sogno spesso ci parla prospetticamente di quello che sarà il percorso dell’analisi. Jung, sulla porta della sua abitazione, scriverà una frase dell’oracolo di Delfi: “Vocatus atque non vocatus Deus aderit” (“Dio, chiamato o non chiamato, si manifesta”). Jung fa una trasposizione da Dio all’inconscio per dire che, chiamato o non chiamato, prima o poi comunque l’inconscio si manifesta (l’inconscio tende sempre a rimostrarsi, soprattutto in un percorso di analisi). “I sogni seguono la bocca”: la bocca è quella dell’interprete, dell’analista. I sogni tendono a realizzarsi e a concretizzarsi nella realtà seguendo quella che sarà l’interpretazione dell’analista: bisogna prestare attenzione a non sbagliare l’interpretazione del sogno: potremmo interpretarlo portando alla vita oppure alla morte!
2.7.3.4. FUNZIONE EQUILIBRATRICE
2.7.3.4.1. La funzione equilibratrice è indirizzata al bilanciamento psicologico. È espressione di un’attività dell’inconscio volta a recuperare e a mantenere stabilità tra contenuti psichici consci e inconsci in relazione dialettica tra loro. Jung, in sostanza, sostiene che il sogno ha il principale obiettivo di EQUILIBRARE.
2.7.3.5. FUNZIONE COMPENSATRICE
2.7.3.5.1. La funzione di compensazione è l’elemento di maggiore innovazione del pensiero junghiano sul sogno. Lo scopo primario della compensazione è di evidenziare, rimarcare e segnalare tutti gli atteggiamenti, i pensieri e i comportamenti che nella vita conscia sono stati trascurati e non hanno considerato il punto di vista dell’inconscio. Se una persona che vuole diventare il “capo dei capi” sogna di essere ad una importante riunione con altri dirigenti e che ad un certo punto gli si spacca la sedia e cade a terra, questo potrebbe significare che in realtà lui non possiede gli strumenti necessari per poter diventare davvero un capo. È come se il sogno amplificasse, con le immagini, un qualcosa che non va bene, che gli dice “non è il caso”.
2.7.3.6. COMPENSAZIONE
2.7.3.6.1. La compensazione rappresenta una forma di “autogoverno” dell’organismo psichico ai fini di un “adattamento completo” e reciproco tra l’inconscio e la coscienza. Quando manca la sintonia con l’inconscio, si crea una “lacuna riempita di paura anziché di comprensione”, per colmare la quale lavora la funzione di compensazione come espressione del punto di vista dell’inconscio.
2.7.3.7. FREUD VS JUNG
2.7.3.7.1. eud sosteneva che si sognavano i desideri: “i sogni sono frutto dei desideri rimossi”. Per Jung nei sogni vi è qualcosa da colmare come dissonanza tra l’inconscio e l’atteggiamento cosciente. Gli analisti junghiani sono consapevoli del fatto che i sogni tendono a portare informazioni di eventi che tenderanno ad accadere. I sogni sono come delle “astronavi” che ci portano informazioni dal futuro e dal passato. Jung, scrive: “I sogni preparano, annunciano o mettono in guardia da determinate situazioni assai prima che accadono nella realtà”.
2.7.4. INCONSCIO SECONDO JUNG
2.7.4.1. a concezione junghiana di inconscio si differenzia da quella di Freud in tre punti fondamentali: l’inconscio ha un corso di sviluppo autonomo; l’inconscio è complementare alla coscienza (vi è una dinamica tra conscio e inconscio); è la sede delle immagini primordiali e universali che Jung stesso chiamerà archetipi.
2.7.4.2. IMAGO
2.7.4.2.1. Il concetto di Imago era stato uno dei più diffusi tra gli psicoanalisti intorno al 1907, ma poi fu in qualche modo abbandonato. Jung propose invece di chiamare “Imago” la rappresentazione soggettiva delle immagini del padre e della madre. Giunse alla conclusione che vi era nella psiche umana un’immagine preesistente inconscia della donna.
2.7.4.3. INCONSCIO PERSONALE E COLLETTIVO
2.7.4.3.1. PERSONALE
2.7.4.3.2. COLLETTIVO
2.7.5. L'INCONSCIO
2.7.5.1. GLI ARCHETIPI
2.7.5.1.1. Nell’archetipo sono presenti le categorie e le energie aprioristiche che rendono possibili le esperienze individuali. Gli archetipi sono riconoscibili in comportamenti esteriori che si raggruppano intorno alle esperienze basilari e universali della vita quali la nascita, la maternità, la paternità, il matrimonio, la separazione e la morte. All’archetipo della morte, per esempio, è connesso il silenzio, gli abiti neri, il lutto. Se noi partecipiamo a un funerale o a un battesimo, pensiamo ai climi differenti: nella nascita abbiamo colori, vivacità e gioia, nella morte – come archetipo nella cultura cristiana – abbiamo elementi quasi tutti negativi. Nell’archetipo della cultura indù, dove vi è la credenza della reincarnazione, vi sono anche canti, gioia e colori sgargianti intorno al tema della morte.
2.7.5.2. LE FUNZIONI
2.7.5.2.1. LA FUNZIONE EQUILIBRATICE
2.7.5.2.2. FUNZIONE COMPENSATRICE
2.7.6. IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE
2.7.6.1. Il termine “individuazione” risale a Gerard Dorn, un alchimista del XVI secolo che è stato ripreso dal filosofo Schopenhauer. Entrambi parlarono di principium individuationis, il processo di formazione e caratterizzazione del singolo individuo psicologico come essere distinto dalla generalità e dalla psicologia collettiva. L’individuazione è un processo di differenziazione che rappresenta un ampliamento della sfera della coscienza e ha per meta lo sviluppo della personalità individuale. L’opus individuativa è più attinente alla seconda metà della vita e l’analisi si limita a creare un ambiente favorevole al processo individuativo. Il processo di individuazione rappresenta il fine ultimo della terapia analitica, attraverso un percorso che consente di “diventare se stessi” come soggetto unico, differenziato da ogni altro. In analisi l’individuazione si raggiunge osservando i propri sogni, cosa questi “chiedono” nella realizzazione della propria realizzazione personale (Freud vedeva i sogni come “espressione del desiderio”, per Jung i sogni tendevano invece a sviluppare il proprio mito personale).
2.7.6.2. INDIVIDUARSI
2.7.6.2.1. significa non rispondere alle esigenze della società o dei genitori, ma rispondere alle proprie esigenze.
2.7.6.3. LA FUNZIONE TRASCENDENTE
2.7.6.3.1. La funzione trascendente propone quelle linee di sviluppo individuali che non potrebbero essere mai raggiunte per la via già tracciata da norme collettive e fornisce il passaggio da un atteggiamento all’altro attraverso la formazione simbolica. Nel prologo della propria autobiografia, Jung scrive: “La mia vita è la storia di un’autorealizzazione dell’inconscio; tutto ciò che si trova nel profondo dell’inconscio tende a manifestarsi al di fuori, e la personalità, a sua volta, desidera evolversi oltre i suoi fattori inconsci, che la condizionano, e sperimentano se stessa come totalità (…) che cosa noi siamo per la nostra visione interiore, e cosa sia l’uomo sembra essere sub specie aeternitatis, può essere espresso solo con un mito; il mito è più individuale, rappresenta la vita con più precisione della scienza (…) ecco perché, a ottantatré anni, mi sono accinto a narrare il mio mito personale. Posso fare solo dichiarazioni immediati, soltanto raccontare delle storie; e il problema non è quello di stabilire se esse siano o no vere, perché l’unica domanda da porre è se ciò che racconto è la mia favola, la mia verità”. Il proprio mito personale, che si evince dai sogni, fonda la struttura profonda della propria personalità e di quello che è da percorrere nella vita.
2.7.7. I TIPI PSICOLOGICI
2.7.7.1. ATTEGGIAMENTI
2.7.7.1.1. INTROVERSO
2.7.7.1.2. ESTROVERSO
2.7.7.2. FUNZIONI
2.7.7.2.1. FUNZIONI RAZIONALI
2.7.7.2.2. FUNZIONI IRRAZIONALI
2.7.8. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.8. LACAN
2.8.1. INTRODUZIONE
2.8.2. 4 CONCETTI FONDAMENTALI PSICOANALISI
2.8.2.1. INCONSCIO
2.8.2.1.1. DIFFERENZE FREUD E LACAN
2.8.2.1.2. SIGNIFICATO
2.8.2.1.3. SIGNIFICANTE
2.8.2.2. PULSIONE
2.8.2.3. TRANFERT
2.8.2.4. RIPETIZIONE
2.8.3. 3 REGISTRI
2.8.3.1. nodo di borromeo
2.8.4. LA METAFORA PATERNA
2.8.4.1. Per Lacan, il padre è una metafora, vale a dire che è un significante che sostituisce un altro significante, ovvero sostituisce il significante materno, legato al significato x. Fort-da: il gioco del rocchetto (Fort: via, da: qui). Un bambino, parente di Freud, sta giocando con un rocchetto e un filo. Ad un certo punto lancia via il rocchetto (fort) e poi lo ritira a sé (da), facendolo un paio di volte. Questa scena mette in luce la sparizione e la riapparizione dell’oggetto (non c’è più, ora è tornato). Secondo Freud questa era la rappresentazione della rinuncia pulsionale compiuta per consentire alla madre di andare via. A partire da questo semplice gioco possiamo dedurre che l’esperienza spiacevole dello svezzamento materno genera apparentemente uno stato passivo del bambino (il bambino è passivo ma, in un secondo momento, riproduce questa stessa scena assumendo una parte attiva). A questo punto il bambino può lasciare la madre e, quindi, può accedere al simbolico (perché da uno stato passivo in cui la madre se ne va e lui si sente impotente, finalmente può rovesciare la situazione e diventare soggetto attivo). In sintesi: prima il bambino è OGGETTO dell’allontanamento, dopo è SOGGETTO (apprende la capacità di padroneggiare l’oggetto).
2.8.4.1.1. can riprenderà l’episodio del gioco del rocchetto di Freud dandone una propria interpretazione. Nel gioco del rocchetto vi sono, secondo Lacan, vari elementi: • S1: prima “iscrizione significante”, è il significante materno; • s1: è l’idea del desiderio della madre (è il significato); • S2: si sostituisce completamente al significante materno (Lacan lo chiama il Nome-Del-Padre); • s2: è il significato. S1 ® S2 s1 ® s2 ® S = significante, s = significato L’ingresso del bambino nella società è determinato dall’accesso all’ordine simbolico, il luogo dei significati sociali.
2.8.5. STADIO DELLO SPECCHIO E L’ACCESSO ALL’IMMAGINARI
2.8.5.1. o “stadio dello specchio”, secondo Lacan, avviene tra i 6 e i 18 mesi di vita. In questo periodo il bambino transita da uno stato del proprio corpo come “frammentato” a un corpo unificato. Il bambino - in sostanza - inizia a riconoscersi allo specchio, a diventare consapevole di sé stesso, recuperando nell’immagine riflessa la totalità del suo corpo, fino a quel momento esperito frammentariamente. All’inizio, il bambino, posto davanti allo specchio da un adulto, confonde immagine con realtà; protende la mano verso l’immagine e guarda dietro lo specchio per ritrovarla. In un secondo momento, intuisce che l’immagine riflessa non è reale e distingue tra loro le immagini di sé e dell’adulto, superando l’iniziale confusione.
2.8.5.1.1. CORPO IN FRAMMENTI---> CORPO UNIFICATO
2.8.6. NEVROSI E PSICOSI
2.8.6.1. Il DSM e i manuali diagnostici in generale si basano sui sintomi. Gli psicoanalisti lacaniani li utilizzano, ma sono dell’idea che “non sono sufficienti”. Al di là dei sintomi, ciò che importa maggiormente a uno psicoanalista lacaniano è la struttura che vi è in gioco. La sua diagnosi, dunque è una diagnosi strutturale. Secondo Lacan nelle psicosi si assiste a un “vuoto” completo di senso, ovvero a una difficoltà a produrre una differenziazione tra significante e significato. Nelle psicosi, inoltre, non si assiste all’accesso al simbolico.
2.8.6.1.1. NEVROSI
2.8.6.1.2. PSICOSI
2.8.7. PULSIONE
2.8.7.1. Lacan la chiama “oggetto piccolo a” (® vedi “nodo Borromeo”). La pulsione si iscrive nel campo dell’Altro, è propriamente ciò che interviene nella domanda dell’Altro. L’oggetto piccolo a, in sostanza, è come se fosse un desiderio di un qualcosa che però non è mai completamente raggiungibile o “catturabile” (l’oggetto cibo, l’oggetto fumo ecc.). Ciò a cui mira il soggetto, per Lacan, è il godimento. Il godimento è necessario per ciascuno di noi, purché sia limitato (nelle psicosi, per esempio, si assiste spesso a fasi di godimento estreme e ininterrotte - es: il soggetto guarda la tv giorno e notte “dimenticandosi” persino di mangiare).
2.8.8. TRANSFERT E RIPETIZIONE
2.8.8.1. Sono due concetti correlati fra loro. Il transfert, per Lacan, è il “dispositivo” della cura analitica. La ripetizione, invece, è un qualcosa che si manifesta nel transfert. Se per Freud il transfert poteva essere sia “motore” che “ostacolo” della cura, per Lacan altro non era che la messa in atto della realtà inconscia.
2.8.9. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.9. BION
2.9.1. INTRODUZIONE
2.9.2. OGGETTO MENTALE
2.9.2.1. Che cos’è l’oggetto mentale per Bion? L’oggetto mentale, per Bion, ha una stoffa diversa rispetto agli oggetti riscontrati da Freud e dalla Klein. È una trasformazione, una messa in forma di ciò che proviene dal corpo (aspetti sensoriali, emozionali e affettivi). Questa messa in forma di ciò che proviene dal corpo si esprime e trova la sua risoluzione in forma di pensiero. Lo stesso Bion sostiene che: “Non si può distinguere una sensazione fisica da un qualcosa di mentale; è un insieme, come se fosse una “matassa”, una modalità per elaborare ciò che proviene dal corpo”. Quando parliamo di Bion, quindi, è praticamente impossibile distinguere ciò che è fisico da ciò che è mentale; è un tutt’uno (alcuni autori definiscono il pensiero di Bion come un “approccio psicosomatico” ® psiche e soma vanno a “braccetto”). Per Bion il corpo è “psicologico”, non meccanicistico come quello di Freud: “Il corpo invoca psichicità”. Questa psichicità e questi vissuti emotivi, per Bion, possono essere: • coordinati; • scoordinati. Vi è un’energia, per Bion, che motiva l’attività psichica e che va ricercata nel vissuto corporeo (noi viviamo determinate esperienze corporee e gli diamo forma come facciamo con il pensiero). Altro concetto importante per Bion è quello dell’esperienza e dell’apprendimento (condizione della crescita psichica): il pensiero cerca di creare un collegamento fra le varie esperienze. Per Bion ognuno di noi, nella propria vita, vive “momenti di catastrofe”, situazioni di crisi in cui raggiungiamo un down (momenti di destrutturazione) e poi, necessariamente, dobbiamo risalire (ristrutturazione). Tutte queste concezioni permetteranno a Bion di studiare e approfondire le teorie dei gruppi. Momenti di catastrofe = down (momento di destrutturazione) ® up (momento di ristrutturazione)
2.9.3. I GRUPPI
2.9.3.1. Noi nasciamo con una tendenza innata a fare gruppo, questa tendenza all’aggregazione è per Bion irrazionale e del tutto implicita. Bion istituì una “terapia di gruppo”; la cui finalità principale era quella di supportare i soldati che avevano subito diversi traumi durante la guerra (disforia, depressione, disturbi d’ansia e via dicendo). In questi gruppi, ai partecipanti, venivano offerte delle attività di collaborazione e si chiedeva loro di condividere i propri pensieri e le proprie emozioni. Bion, in questi gruppi, non interveniva, ma stava semplicemente ad osservare le dinamiche che si venivano a creare. Notò che le dinamiche osservate tendevano a ripetersi in ogni gruppo quasi come se fossero un vero e proprio copione. Poi decise di andare “oltre”, parlando al gruppo stesso di queste dinamiche. Bion raccontò loro di avere l’impressione che il suo intervento non li avrebbe aiutati e, a questo proposito, gli individui del gruppo si meravigliarono e ci rimasero male. Quello che fece Bion, fu un qualcosa di strategico e di intenzionale: grazie a questo Bion colse il fatto che in ogni Appunti a cura di Simone Quagliata 66 gruppo è sempre presente un’aspettativa nei confronti di un capo o di un leader. In sostanza: l’aspettativa nei confronti di un leader o di un capo c’è sempre, in qualsiasi gruppo.
2.9.3.2. GRUPPO DI LAVORO
2.9.3.2.1. A questo proposito Bion istituì un primo concetto, quello del gruppo di lavoro. Nel gruppo di lavoro è sempre presente una dimensione del compito e dell’obiettivo: ogni gruppo, razionalmente, ha presente quali siano i propri obiettivi (es. guarire, costruire un progetto, battersi per una causa ecc.). Il conflitto di gruppo, secondo Bion, nasce proprio dalla messa in atto e dalla condivisione di obiettivi razionali. Il conflitto - secondo Bion - nasce dal gruppo razionale (e quindi dal gruppo di lavoro): quando vi è la dimensione del compito e dell’obiettivo, quindi, nasce il conflitto. Vi è dunque una parte intrapsichica (Freud), ma anche un qualcosa di razionale (evidente ed esplicitata). Il gruppo di lavoro ha un’attività, attività che può essere osteggiata da tendenze di tipo emotivo che impediscono l’attuazione degli obiettivi razionali che ogni individuo si era posto. Bion sostiene che non bisogna tanto ragionare in termini di singoli individui che perseguono un obiettivo razionale, ma dobbiamo ragionare sul gruppo come entità che va a prescindere dai singoli individui: il gruppo possiede una propria attività mentale che presuppone un’autoconservazione. In sostanza: vi sono sì i singoli individui che fanno parte del gruppo, ma anche un gruppo che possiede una propria attività mentale. Da questo presupposto Bion individuerà un secondo tipo di gruppo: il gruppo di base.
2.9.3.3. GRUPPO DI BASE
2.9.3.3.1. = tutto ciò che nel gruppo è inconscio, sommerso) Il gruppo di base è l’insieme dei fenomeni emotivi inconsci che premono sul gruppo di lavoro e che presuppongono delle modalità di funzionamento, ovvero gli assunti di base. Quindi… Vi è una parte esplicita e razionale ® gruppo di lavoro Vi è una parte inconscia e sommersa ® gruppo di base (Gruppo di lavoro e gruppo di base vanno sempre “a braccetto” e s’influenzano reciprocamente).
2.9.3.3.2. ASSUNTI DI BASE
2.9.3.3.3. ALTRI CONCETTI FONDAMENTALI NEL GRUPPO
2.9.4. PENSIERO COME CARDINE DELLO SVILUPPO
2.9.4.1. Ad un certo punto Bion comincia a parlarci di funzioni e di elementi. Il termine funzione si riferisce ad un’attività mentale che è caratterizzata e generata da una serie di fattori che interagiscono fra loro.
2.9.4.2. FUNZIONE ALFA
2.9.4.2.1. uta. Funzione α (Alfa) - funzione di personalità Il pensiero è un qualcosa che “lega” il vissuto corporeo e le esperienze dell’individuo. Per poter apprendere dall’esperienza, però, vi deve essere una funzione (denominata da Bion “funzione α”) che operi sulla consapevolezza dell’esperienza emotiva. Io, soggetto, devo avere un qualcosa, una funzione, che mi permetta di rappresentarmi razionalmente l’esperienza che ho vissuto. La funzione α, in pratica, “trasforma” dei dati “meramente” sensoriali, che provengono dal corpo, in elementi α. Funzione α ® elementi α Esempio di funzione α: la mamma chiede al bambino “piangi perché hai male al pancino? Hai male, vero?” ↓ In questo modo la mamma sta svolgendo per il bambino la funzione α; il piccolo “incorpora” gradualmente gli elementi α imparando ad attribuire un significato alle sensazioni emotive e, nello stesso tempo, sviluppa a sua volta la capacità di svolgere la funzione α (cioè la capacità di pensare)
2.9.4.3. ELEMENTI BETA
2.9.4.3.1. Gli elementi ß sono la “premessa del pensiero”, sono proto-pensieri grezzi, non organizzati e connessi alla corporeità vissuta.
2.9.4.4. PRE CONCEZIONE E CONCEZIONE LA FORMAZIONE DEL PENSIERO
2.9.4.4.1. La funzione α, chiaramente, migliora con il tempo e soprattutto con l’esperienza. Da cosa nasce questa esperienza? Chiaramente dalle prime relazioni, in particolare con la relazione materna. Bion, a tal proposito, ci dice che la funzione α attua un passaggio dalla pre-concezione alla concezione: • pre-concezione: è una forma di pensiero che consiste in una aspettativa (io mi aspetto qualche cosa dall’altro); • concezione: è l’aspettativa che viene esaudita. Secondo Bion, questo rappresenta l’inizio della formazione del pensiero: Bion non ci parla di pulsioni, di istinti, ma ci parla di pensiero come elemento fondamentale per la crescita psichica. Chi è il leader? “Secondo me il capo è un prodotto dell’assunto di base così come ogni altro membro del gruppo e ritengo che questo ci si debba aspettare se si immagina che l’identificazione dell’individuo con il capo non dipenda soltanto dall’introiezione, ma anche dal contemporaneo processo di identificazione proiettiva” (Bion, 1961). Non è dunque il leader a creare il gruppo; il leader è un membro del gruppo che soddisfa le caratteristiche della leadership proiettate nel gruppo in uno specifico momento (compreso gli assunti di base).
2.9.4.5. IL RUOLO MATERNO
2.9.4.5.1. Perché è fondamentale per Bion il ruolo materno? Per Bion sono fondamentali tutti i comportamenti che la madre mette in atto per appagare i bisogni d’amore del bambino. Che cos’è la rêverie materna? Con il termine “rêverie materna”, Bion intende la capacità della madre di accogliere le sensazioni del bambino e fornire loro un significato (la capacità di accogliere le sensazioni del bambino indifferenziate e prive di forma, cioè gli elementi ß). Quindi: la madre, all’inizio, svolge il ruolo di “CONTENITORE” cioè elabora, trasforma e restituisce il materiale grezzo al bambino. La madre, in sostanza, elabora per conto del bambino del materiale grezzo che, successivamente, lo stesso bambino introietterà. Il bambino, in base al feedback ricevuto dalla madre, potrà introiettare un oggetto buono oppure un oggetto cattivo. L’oggetto, quindi, non è buono/cattivo di per sé, ma dipende da come la madre lo restituisce al bambino. Se la madre non riesce a restituire al piccolo le sue emozioni e sensazioni in forma “pensabile”, il piccolo - oltre a provare odio, frustrazione e sentimenti negativi in generale - sarà composto esclusivamente da elementi ß. La funzione α, quindi, nasce proprio grazie alla teoria del contenitore/contenuto. Il “CONTENUTO”, invece, è il materiale psichico (prevalentemente emozioni arcaiche) senza forma e caotico del bambino, a cui il contenitore materno dà senso e significato. NB: notare le somiglianze del pensiero di Bion e di Lacan rispetto al concetto di “contenitore/contenuto” e dello “stadio dello specchio”. “La madre ha una funzione prioritaria: avvia il pensiero del proprio bambino”.
2.9.5. ASSETTI MOTIVAZIONALI
2.9.5.1. AMORE
2.9.5.1.1. amore (L ® love): nella relazione posso sviluppare sentimenti d’amore;
2.9.5.2. ODIO
2.9.5.2.1. odio (H ® hate): nella relazione posso sviluppare sentimenti di odio;
2.9.5.3. CONOSCENZA
2.9.5.3.1. conoscenza (K ® knowiedge): è per Bion il legame fondamentale - se io non apprendo, in qualche modo non posso sviluppare un legame. Il legame K è per Bion anche uno stato di ricerca definito in questo caso con il termine di “ -K” (meno K). – K significa “non comprensione” (può succedere che la mamma, per esempio attraverso il seno, invii al bambino dei segnali ambigui). In casi come questi il bambino risulterà confuso senza riuscire a comprendere che cosa è accaduto (esempio: il seno interviene non quando il bambino lo vuole e ne ha bisogno, ma solo quando la madre lo ritiene opportuno). Il bambino, in pratica, riceve dalla madre elementi privi di senso, cioè problemi che non sono stati elaborati dal “contenitore” materno. Gli elementi non trasformati, che rimangono “grezzi”, possono far insorgere delle psicosi. Esempio (allucinazioni visive dello psicotico): è come se vi fosse una messa in atto di un materiale confuso e non organizzato, un qualcosa a cui è difficile attribuire un senso (Bion li definisce “elementi bizzarri”, cioè elementi grezzi, non trasformati, che possono riaffiorare quasi imponendosi in questo modo).
2.9.5.4. Questi tre legami fondamentali non solo li viviamo tutti noi nella nostra quotidianità, ma secondo Bion si possono osservare anche in una relazione terapeutica nei confronti di un analista (tutto questo attraverso il transfert, anche se Bion non parlò molto di questo concetto). L’analista, sempre secondo Bion, deve tenere conto dell’emergere di queste relazioni (anche per comprendere se il percorso deve andare avanti oppure no)
2.9.6. TEORIA DELLE TRASFORMAZIONI
2.9.6.1. È una teoria che prende spunto dal concetto di transfert e che descrive tutte le trasformazioni che avvengono dal materiale che il paziente porta in seduta dall’analista. Il materiale che il paziente porta all’analista si ancora a una condizione iniziale che si è verificata. Nel corso della seduta, questo materiale verrà piano piano “trasformato”. Bion utilizza delle lettere per spiegare questo processo di trasformazione: • O (= origine); • T (= trasformazione); • T α (= se il processo è in continua evoluzione); • T ß (= è il prodotto finale dell’avvenuta trasformazione del materiale grezzo originario). Secondo Bion, dunque, durante la seduta l’esperienza originaria viene trasformata in una rappresentazione portando ad un prodotto finale. Come viene trasformata questa esperienza durante una seduta terapeutica? (tipi di trasformazioni) • trasformazione proiettiva; • trasformazione rigida; • trasformazione in allucinosi (è tipica del funzionamento psicotico che avviene, per esempio, nelle terapie di gruppo e che si manifesta soprattutto con l’invidia e l’aggressività).
2.9.7. LA PERSONALITÀ PSICOTICA SECONDO BION
2.9.7.1. Bion ci dice che la causa primaria della psicopatologia di tipo psicotico è da rintracciare nella relazione madre-bambino, nella rêverie materna, nella questione contenitore/contenuto (una madre non idonea, non adeguata, che invierà al proprio bambino degli elementi non organizzati ® tutto ciò, inevitabilmente, porrà le basi per un figlio con una personalità di tipo psicotico).
2.9.8. IL CAMBIAMENTO CATASTROFICO
2.9.8.1. Inizialmente Bion, quando parlava di “catastrofe”, lo faceva con un’accezione negativa. Successivamente cambiò idea cominciando piano piano a considerare il “cambiamento catastrofico” come un qualcosa di positivo: con il termine “senso di catastrofe” s’intende un qualunque evento che avvia e favorisce un salto nella crescita mentale. Per Bion, inevitabilmente, ognuno di noi nella propria vita deve necessariamente passare da una catastrofe per poterne uscire rinnovato e migliore di prima, ovvero con una reale crescita psichica e del pensiero (= quello che non uccide fortifica). Solo all’interno di una catastrofe ci impegniamo attivamente a tirare fuori le nostre migliori risorse. Bion ci parla anche di “insight”, definendolo come un qualcosa che appartiene all’analista, quel punto non descrivibile - ma che accade, che avviene - e che permette di avviare il processo terapeutico.
2.9.9. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.10. BOWLBY
2.10.1. INTRODUZIONE
2.10.2. ESPERIMENTI DI HARLOW CON PICCOLI DI MACACO
2.10.2.1. Cuccioli cresciuti con due sostituti materni: il primo, in metallo, e l’altro fatto di tessuto morbido. È presente un dispersore di cibo su uno dei due sostituti (su quello in metallo). Dei cuccioli di scimmia venivano sottratti dalle madri e messi accanto ai due surrogati artificiali. Si notò che i due piccoli ricercavano il cibo dalla scimmia che distribuiva cibo (perché avevano fame e dovevano soddisfare il bisogno alimentare), ma che subito dopo ricercavano immediatamente il calore della scimmia finta morbida. Harlow, grazie a questo esperimento, osservò che vi era sì la necessità di cibarsi, ma che subito dopo prevaleva la necessità di vicinanza a un qualcosa che emanava calore e accoglienza. Bowlby, riprendendo questi studi, riuscì a confermare le sue ipotesi: in ognuno di noi vi è una funzione biologia di “protezione”, con una propria motivazione interna che è distinta dal “mero” comportamento automatico alimentare. Da qui la teoria dell’attaccamento prese un ruolo fondamentale: l’attaccamento è ciò che avvia la relazione fra madre e bambino.
2.10.3. ATTACCAMENTO
2.10.3.1. L’attaccamento, come lo definiva lo stesso Bowlby, è una motivazione primaria: in ognuno di noi vi è una tendenza innata, una predisposizione biologica a legarsi all’altro (soprattutto rispetto alla prima figura di riferimento). Se questa predisposizione, per un qualsiasi motivo, viene ostacolata dall’esterno, può insorgere una psicopatologia. La capacità a stabilire un legame con gli altri, secondo Bowlby, appartiene a tutti ed è universale. La capacità di mantenere questo attaccamento, invece, dipende da questioni culturali e sociali. Bowlby sottolinea che prima viene il bisogno del nutrimento, ma che subito dopo appare il bisogno e la necessità dell’attaccamento.
2.10.3.2. DIFFERENZA CON L'APPROCCIO FREUDIANO
2.10.3.2.1. ual è la differenza rispetto all’approccio freudiano? L’allattamento presuppone un appagamento di una pulsione; per Freud, dunque, la meta è la scarica e il soddisfacimento della pulsione. Per Bowlby la motivazione primaria non è la “scarica” e l’allentamento della tensione, ma è la necessità di stare accanto ad un’altra persona (in particolar modo la prima figura di riferimento). L’oggetto, quindi, cambia: da mezzo (Freud) a necessità (Bowlby).
2.10.3.3. COMPORTAMENTO DI ATTACCAMENTO
2.10.3.3.1. È il comportamento che il bambino mette in atto, frutto dell’apprendimento, al fine di assicurarsi, stabilizzare e mantenere la vicinanza di un’altra persona
2.10.3.4. SISTEMA DI ATTACCAMENTO
2.10.3.4.1. È un qualcosa di cui “siamo dotati”, con cui “nasciamo”. Siamo biologicamente predisposti ad avere questo sistema. È innato.
2.10.3.5. ELEMENTI GENERALI
2.10.3.5.1. Che cos’è una buona relazione d’attaccamento? Si parla di buona relazione d’attaccamento quando sono presenti queste tre caratteristiche: • ricerca di vicinanza; • base sicura (mi devo rappresentare quella persona come una base sicura); • protesta per la separazione dalla figura d’attaccamento. Inizialmente Bowlby parlava di monotropismo poiché era dell’idea che, soprattutto all’inizio, vi era “attaccamento” nei confronti di un’unica singola persona. Dopo l’attaccamento a questa figura, nel corso della vita, la persona può sviluppare successivamente altri attaccamenti (attaccamenti multipli). Bowlby parlava anche della presenza di un “periodo sensibile” (primo anno di vita) definendolo come un periodo privilegiato in cui l’individuo è maggiormente predisposto a sviluppare un attaccamento.
2.10.3.6. LO SVILUPPO ONTOGENICO DEL SISTEMA DI ATTACCAMENTO
2.10.3.6.1. Orientamento e segnali senza discriminazione della persona ----------------------------------------------------------------------- Orientamento e segnali verso una o più persone discriminate ----------------------------------------------------------------------- Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata mediante la locomozione e mediante segnali ----------------------------------------------------------------------- Rapporto reciproco diretto secondo lo scopo
2.10.3.7. MODELLI OPERATIVI INTERNI
2.10.3.7.1. I modelli operativi interni sono modelli rappresentazionali di sé stessi, degli altri e delle relazioni su esperienze interattive ripetute: io faccio esperienza di come mi relaziono agli altri e di come gli altri si relazionano a me e queste esperienze le “interiorizzo”, le faccio mie e me le porto dietro per tutta la vita. Esempio del partner: alcune persone ripropongono con il proprio partner il modello relazionale che avevano impostato con le proprie figure di riferimento e con il proprio nucleo familiare. Questo “bagaglio” ci serve per predire e prevedere il comportamento altrui, ma anche per relazionarci nel giusto modo con gli altri. Bowlby sosteneva che i modelli operativi interni erano anche alla base del transfert. I modelli operativi interni iniziano nell’infanzia, ma poi perdurano per tutta la vita. Iniziano con le figure di attaccamento “precoci” (genitoriali), successivamente si ampliano nei confronti di altre figure.
2.10.3.8. FIGURE DI ATTACCAMENTO
2.10.3.8.1. SICURA
2.10.3.8.2. INSICURA
2.10.3.9. TIPOLOGIE DI ATTACCAMENTO
2.10.3.9.1. ATTACCAMENTO INSICURO/ANSIOSO
2.10.3.9.2. ATTACCAMENTO EVITANTE
2.10.3.9.3. ATTACCAMENTO AMBIVALENTE
2.10.3.9.4. ATTACCAMENTO DISORGANIZZATO
2.10.4. IMPRINTING
2.10.4.1. È una forma di apprendimento che i piccoli di alcune specie realizzano stando a contatto con i genitori in un preciso periodo della loro vita. Questi cuccioli, in sostanza, apprendono “come reagire” agli stimoli che il genitore gli rimanda. L’imprinting, dunque, è come se fosse una sorta di forma di comunicazione. Lorenz aveva osservato che vi erano alcune specie di animali, per esempio le cornacchie, che se allevati da un sostituto materno (di una specie differente), dopo un po’ di vita indipendente e autonoma, tornavano a corteggiare individui della stessa specie della madre adottiva (cioè individui di specie diverse). Questo è un elemento importante: conferma che l’imprinting e l’avvicinamento della figura materna e della scelta sessuale sono due elementi assolutamente inseparabili
2.10.5. SEPARAZIONE E LUTTO
2.10.5.1. Fece degli studi su 44 giovani delinquenti (6-16 anni). Si interrogò del perché questi giovani avessero un comportamento disadattivo e delinquenziale. Secondo Bowlby tali comportamenti erano giustificati da delle problematiche da rintracciare nella loro infanzia rispetto alle loro relazioni d’attaccamento. Lo studio mise in evidenza che i soggetti avevano subito durante l’infanzia una separazione precoce con la madre e fece notare che, all’interno dello stesso gruppo, vi erano soggetti definiti dallo stesso Bowlby come “anaffettivi psicopatici”.
2.10.5.2. ANAFFETTIVI PSICOPATICI
2.10.5.2.1. “Anaffettivi psicopatici” significa che questi bambini, alla nascita, erano propensi e predisposti come tutti a sviluppare un attaccamento con un'altra persona, ma ad un certo punto è successo una di queste due cose: • la figura era assente (assenza fisica e/o emotiva) - in questo modo il bambino ha dovuto “arrangiarsi” da solo (l’altro non c’è, non mi può aiutare, allora mi arrangio da solo…); notare l’analogia con Winnicott e con il falso sé; • oppure la figura non ricambia il bisogno d’amore del bambino. Anaffettivo ® non sento (perché nessuno mi ha permesso questo processo) Psicopatico ® (nessuno ha saputo rispondere per me alle mie esigenze)
2.10.5.3. SEPARAZIONE
2.10.5.3.1. PROTESTA
2.10.5.3.2. ISOLAMENTO/DISPERAZIONE
2.10.5.3.3. DISTACCO
2.10.5.4. L'ELABORAZIONE DEL LUTTO
2.10.5.4.1. Torpore, stordimento Incredulità, calma apparente e innaturale, emozioni non espresse. Struggimento, ricerca dell'oggetto perduto Collera, pianto, angoscia, insonnia, irrequietezza, pensiero ossessivo del defunto. Disorganizzazione e disperazione Disperazione, depressione, senso di solitudine, riconoscimento che la perdità è definitiva. Riorganizzazione Ridefinizione del Sè e della situazione, nuovi ruoli e nuove capacità.
2.10.6. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.11. AINSWORTH
2.11.1. INTRODUZIONE
2.11.2. I SUOI STUDI
2.11.2.1. UGANDA
2.11.2.1.1. Coinvolse 28 bambini divisi in tre gruppi (età 2 anni circa). L’obiettivo dello studio era quello di osservare il comportamento dei bambini nei confronti della figura della madre. Lo studio permise di “classificare” i bambini in base alla tipologia di attaccamento.
2.11.2.2. BALTIMORA
2.11.2.2.1. Studio longitudinale sulle differenze individuali nell’attaccamento. L’obiettivo era quello di osservare l’interazione madre-bambino da parte del ricercatore, che si recava a casa dei partecipanti a intervalli regolari. Intorno all’anno di vita del bambino, le madri venivano invitate a portare i bambini in un laboratorio per effettuare un’osservazione standardizzata: la Strange Situation. La Strange Situation è utilizzata ancora oggi perché permette ai clinici e ai ricercatori di studiare le modalità di interazione tra madre e bambino. L’intera procedura dell’esperimento è solitamente video-registrata.
2.11.3. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.12. FROMM
2.12.1. INTRODUZIONE
2.12.2. PSICOANALISI UMANISTICA
2.12.2.1. È una sorta di “ibrido” fra filosofia e storia nato grazie allo psichiatra Wilhelm Reich intorno agli anni ’20 secondo cui la salute psichica dell’uomo non poteva realizzarsi se non con l’abbattimento della struttura sociale contingente. Tutto ciò poteva avvenire solamente grazie ad una “rivoluzione” massiva. Fromm, per le sue teorie, prese ispirazione proprio dalla psicoanalisi umanistica e da Wilhelm Reich. Fromm, dunque, integra più discipline (storia, filosofia, sociologia) focalizzandosi sui rapporti tra gli individui, i gruppi e la società.
2.12.3. ESSERE/AVERE
2.12.3.1. Secondo il pensiero di Fromm, ciascuno di noi è caratterizzato da due aspetti: Essere e Avere. Essere e Avere sono due elementi che possono fornire la spiegazione del funzionamento di un individuo e di come questo possa stare al mondo vivendo nella propria società di appartenenza. Sono due modi di vivere, due modi di come un individuo definisce sé stesso e il mondo.
2.12.3.1.1. ESSERE
2.12.3.1.2. AVERE
2.12.3.2. Come elabora tutto questo Fromm? Si focalizza principalmente su due autori: • Sigmund Freud: secondo lui Freud era un “borghese” che aveva concettualizzato l’uomo come se fosse una “macchina” caratterizzata da un’energia. Secondo Fromm, Freud era “figlio” di quell’epoca e di quel periodo culturale e quindi, le sue teorie, non potevano essere diverse da quelle che sono state. • Carl Marx: secondo Fromm era l’autore che poteva contrastare Freud; Marx vedeva le persone determinate dalla loro società: l’uomo vive in un gruppo e, in questo gruppo, fa crescere la propria personalità. In sintesi: secondo Fromm, dunque, il funzionamento psichico dell’uomo non è riducibile a delle forze intrapsichiche e inconsce ma, in un’ottica marxista, è condizionato dal momento storico, dalla società e dai principi economici. Fromm sottolinea l’influenza dei fattori socio-biologici, della storia, dell’economia e della struttura della società.
2.12.4. SINTOMI
2.12.4.1. Focalizzando la sua attenzione sulla società, Fromm ci parla di sintomi. I sintomi non sono tanto l’angoscia, il trauma non risolto o il conflitto intrapsichico: i sintomi sono il prodotto di un’alienazione del bisogno dell’uomo di essere massificato (AVERE ® la società m’impone di essere passivo ® io riesco a vivere perché mi adatto alle richieste della società, questo è disfunzionale).
2.12.5. DICOTOMIE ESISTENZIALI
2.12.5.1. L’uomo* è caratterizzato da dilemmi esistenziali. La situazione umana appare costellata di “dicotomie esistenziali”, contraddizioni ineliminabili a cui si può solo reagire secondo dei caratteri individuali e della società: • vita e morte: la vita e la morte sono due realtà contrapposte e incompatibili; • completa realizzazione di sé e brevità dell’esistenza; • individualità separata delle relazioni sociali. * uomo moderno, che vive in un mondo capitalista e individualista, dove lo scopo principale è esclusivamente quello di crescere dal punto di vista produttivo. Quindi, per Fromm, l’uomo è caratterizzato da delle dicotomie esistenziali: come negoziamo, come conviviamo con queste dicotomie? Possiamo soccombere oppure possiamo “trovare” un senso.
2.12.6. BISOGNI ESISTENZIALI
2.12.6.1. BISOGNI ESISTENZIALI
2.12.6.1.1. BISOGNO DI CORRELAZIONI CON GLI ALTRI
2.12.6.1.2. BISOGNO DI TRASCENDENZA
2.12.6.1.3. BISOGNO DI RADICAMENTO
2.12.6.1.4. BISOGNO DI IDENTITÀ
2.12.6.1.5. BISOGNO DI ORIENTAMENTO
2.12.6.2. Secondo Fromm noi uomini abbiamo anche dei bisogni esistenziali. Questi bisogni “nascono” perché noi, inevitabilmente, siamo portati - vivendo in una società - a distaccarci dalla natura. Fromm ci parla di un “Eden”, ovvero di un mondo bellissimo in cui tutti i nostri bisogni vengono appagati, mondo che è destinato a crollare quando ci accorgiamo di essere degli individui e di possedere delle dicotomie esistenziali. Fromm paragona l’Eden come alle prime fasi di vita del bambino, dove grazie alla madre è coccolato e tutti i suoi bisogni e desideri sono immediatamente appagati, Eden che crolla quando il bambino diventa “uomo” ed acquisisce la consapevolezza di vivere “vittima” di una società e di avere dei ruoli. Però, sottolinea Fromm, in età adulta permane una tendenza a voler ritornare in questo Eden, a ricercarlo. A questo proposito Fromm ci parla di bisogni esistenziali tipicamente umani.
2.12.7. LIBERTÀ POSITIVA
2.12.7.1. Fromm ci dice che l’unico rimedio reale per ottenere una realizzazione completa della propria persona all’interno della società è l’amore, l’instaurare rapporti d’amore fraterno con gli altri.
2.12.8. MECCANISMI DI FUGA
2.12.8.1. Le persone che hanno raggiunto una maggiore libertà, sostiene Fromm, diventano sempre più sole: più rappresentiamo un punto fermo per la società, più ci sentiamo soli. L’uomo, prima o poi, si accorge di non possedere un’autentica libertà. E allora come può fuggire da questa non-libertà? Possiamo farlo attraverso quelli che Fromm aveva chiamato “meccanismi di fuga”: • attraverso l’autoritarismo: tendenza a rinunciare all’indipendenza del proprio sé individuale al fine di acquisire sempre più forza (l’individuo vuole stare al mondo, vuole imporsi); può assumere due forme: - masochismo: subisco un’influenza dal mio capo, ma con lo stesso capo m’impongo agli altri; - sadismo: infliggo del male all’altro, lo distruggo (a volte godendo di ciò); • attraverso la distruttività: secondo Fromm esiste una forma estrema di sadismo (aggressività maligna) che l’individuo può mettere in atto col fine di eliminare altre persone dalla propria vita (se non esistono, non possono ferirmi); secondo Fromm esiste anche un’aggressività benigna, messa in atto per salvaguardare la propria persona (è biologicamente adattiva ® bisogno di proteggersi, di proteggere la prole, di difendere il proprio territorio, di tutelarsi ecc.); • attraverso il conformismo.
2.12.9. BIOFILO E NECROFILO
2.12.9.1. BIOLIFO
2.12.9.1.1. È l’amore per la vita, l’attrazione per la crescita, la creazione e la costruzione. l biofilo cerca di influenzare gli altri attraverso la ragione, l’amore e l’esempio.
2.12.9.2. NECROFILO
2.12.9.2.1. Fromm ci dice che l’aggressività maligna è un qualcosa che può raggiungere l’estremo patologico proprio con la necrofilia: si cerca di distruggere l’altro e, addirittura, si arriva ad “amare ciò che è morto”. Fromm fa un’analogia con la società moderna (la società che ci vuole “morti”, che ci esaspera con il lavoro e con la produttività)
2.12.10. ORIENTAMENTO DEL CARATTERE
2.12.10.1. Ognuno di noi è costituito da elementi innati, ma anche da elementi acquisiti. Per Fromm, per esempio, il temperamento ha una componente prevalentemente genetica e consiste in alcune qualità che noi ereditiamo. Nonostante ciò, questa ereditarietà, si integra con delle qualità acquisite: è dall’unione delle qualità acquisite e delle qualità ereditate che si forma il carattere (il carattere, dunque, è un’unione tra elementi ereditati ed elementi acquisiti).
2.12.10.2. ASSIMILAZIONE
2.12.10.2.1. Acquisizione dall’ambiente per soddisfare i propri bisogni (non soddisferemo mai i nostri bisogni reali, ma possiamo attingere dall’ambiente per soddisfarli).
2.12.10.3. SOCIALIZZAZIONE
2.12.10.3.1. ensione verso l’altro, necessità di relazioni.
2.12.10.4. ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
2.12.10.4.1. È basato sul rispetto per gli altri e sul rapportarsi agli altri attivamente e responsabilmente.
2.12.10.5. ORIENTAMENTO NON PRODUTTIVO
2.12.10.5.1. Sono strategie che falliscono nell’avvicinare alla libertà positiva e all’autorealizzazione. Non vi è rispetto dell’altro. Esistono varie tipologie di orientamenti non produttivi: “ricevere cose”; personale; salvaguardare quelle già ottenute; Fromm ci parla anche di elementi produttivi e non produttivi: ognuno forma il proprio carattere sulla base di ciò che acquisisce (genetica) e sulla base di ciò che andrà ad acquisire. Fromm, inoltre, ci parla sia di un carattere “individuale” che di un carattere “culturale” (nei popoli, nelle culture e nelle società). Per fare un esempio: quando un popolo partecipa a una guerra, acquisisce un certo tipo di carattere. ORIENTAMENTI PRODUTTIVI E NON PRODUTTIVI • o. ricettivo: è la sensazione che la fonte di tutte le cose buone sia fuori da sé e che l’unica modalità di rapportarsi al mondo sia • o. appropriativo/sfruttatore: pensa solamente al tornaconto • o. tesaurizzante/accumulatore: cerca di accumulare cose e • o. mercantile/orientato al marketing: sono concentrati nel sembrare persone di successo, spesso sono superficiali
2.12.11. PERSONALITÀ DISTURBATE
2.12.11.1. Estrema dipendenza da una persona o da una cosa; • perdita della propria individualità; • simbiosi incestuosa; • infatuazione di sé stessi (narcisismo); • esame di realtà deficitario (tutto ciò che appartiene alla persona è altamente valutato, mentre tutto il resto è svalutato).
2.12.12. DIFFERENZE E PUNTI DI CONTATTO CON ALTRI AUTORI
2.13. STERN
2.13.1. INTRODUZIONE
2.13.2. INFANT RESEARCH
2.13.2.1. Il modello dello sviluppo infantile elaborato da Stern si colloca all’interno del paradigma scientifico denominato “Infant research” che si è costituito come un’area di ricerca al confine fra psicoanalisi e psicologia evolutiva. Stern inizia ad osservare e ad indagare il mondo del bambino piccolo e tutto questo lo porta a criticare la Mahler e, più in generale, il concetto di narcisismo primario della metapsicologia di Freud. Quello che critica Stern è la questione dello sviluppo scandito da “tappe” che si susseguono una dopo l’altra, ciò implica una critica anche ai concetti di regressione e di fissazione. La concezione “classica” dello psicosviluppo, per Stern, è troppo “meccanicistica” e “deterministica”. Stern “estende” le fasi dello psicosviluppo, cioè ciò che gli altri autori avevano postulato, a tutto il ciclo di vita della persona. Daniel Stern propone un modello dello psicosviluppo che sostiene la precoce capacità del bambino di sperimentare l’emergere di un’organizzazione del Sé sin dai primi mesi di vita (non vi è un’unica fase evolutiva che determina tutto). Vi è per Stern, dunque, un’embrionale differenziazione fra sé e l’altro sin da subito. Il bambino che emerge dalle ricerche di Stern è attivamente impegnato nelle ricerche di stimoli; è un bambino in grado di regolare sin da subito sia la carenza che l’eccesso di tali stimoli. Vi è una predisposizione all’interazione sociale che caratterizza tutto il suo sviluppo. Secondo Stern esiste una sequenza evolutiva che delinea una successione di cambiamenti bio- comportamentali; sono dei “punti di rottura” che fanno emergere nel bambino delle nuove capacità. Ogni step rispetto all’acquisizione di nuove capacità richiede un grado sempre più elevato di regolazione (step by step, passo dopo passo). Vi è, in sostanza, un processo di regolazione e di negoziazione tra madre e bambino. Il modello dello psicosviluppo, secondo Stern, è sicuramente caratterizzato da una forte componente relazionale, ma è anche costituito da un continuo stato di regolazione nella diade madre-bambino (vi è uno scambio reciproco e continuo tra bambino e figura di accudimento). “In breve, la nostra vita mentale, è frutto di una co-creazione, di un dialogo continuo con le menti degli altri, che io chiamo matrice intersoggettiva (…) le due menti creano l’intersoggettività e l’intersoggettività modella le due menti” L’oggetto di studio di Stern, quindi, si rifà sui processi interattivi precoci che il bambino mette in atto già in tenera età: bambino e madre partecipano insieme a tutto ciò in un mondo condiviso.
2.13.3. MOMENTO R
2.13.3.1. Il bambino, per Stern, via via cresce ed acquisisce nuove esperienze e competenze. Secondo lui gli eventi vissuti concorrono a formare un ricordo, così come i vari ricordi possono essere via via assemblati (continuità dell’esperienza) costituendo uno scenario che assume il significato di “prototipo” (momenti R). L’idea di fondo è che nel bambino, l’identificazione di questi caratteri, è una delle tendenze fondamentali che caratterizza ognuno di noi e che conduce ad una categorizzazione progressiva dell’esperienza. Questa categorizzazione porta alla formazione di “prototipi”, definiti come “momenti R”, intesi come rappresentazioni di esperienze mentalmente costruite (caratteri che non variano e che costituiscono molti momenti ricordati e vissuti). In sintesi: è come se vi fosse uno “sfondo” che caratterizza ogni esperienza che faccio; io “incasello” ognuna di queste esperienze e me le rappresento mentalmente sotto forma di ricordi. Uno specifico momento interattivo vissuto, definito da Stern come “momento V”, viene “codificato” in memoria per formare il ricordo di un episodio specifico (momento M). A loro volta, molti ricordi di eventi specifici simili, vengono organizzati insieme e danno vita a un “prototipo”, ossia una rappresentazione di momenti M ordinati in modo da formare un “momento generalizzato”, ovvero una rappresentazione della serie di momenti M. Questa rappresentazione, a sua volta, è chiamata “momento R” e costituisce l’unità gerarchica successiva che poi si proporrà. Analogamente vi sono sequenze di momenti vissuti (scenari V) che divengono, a loro volta, dei ricordi di episodi specifici (scenari M). Molti scenari M vengono organizzati e generalizzati sino a formare uno una rappresentazione detta “scenario R”. Quindi: il bambino, man mano che cresce, acquisisce un repertorio di ricordi sempre più ampio oltre che le competenze per organizzarli. Via via che i bambini accedono a questo sistema, acquistano maggiore capacità di risolvere i problemi. È come se vi fosse una “catena” fra le varie esperienze che porta, in sintesi, a una coerenza del Sé. In Stern, dunque, troviamo una tendenza innata all’organizzazione globale e coerente dell’esperienza. In Stern la psicopatologia deve essere rintracciata nelle interazioni reali della coppia madre- bambino, più che nei processi intrapsichici (quelli “classici” della psicoanalisi).
2.13.4. I MOMENTI MATRICE DEL BAMBINO
2.13.5. LO SVILUPPO DEI SENSI DEL SÈ
2.13.5.1. SENSO DEL SE EMERGENTE
2.13.5.1.1. Nei primi 3 mesi di vita del bambino, le sue esperienze non sono ancora del tutto integrate. Il senso del Sé emergente è basato sulle innate capacità del bambino di fare esperienza sia di sé che dell’altro.
2.13.5.2. SENSO DEL SE NUCLEARE
2.13.5.2.1. Dopo i 2/6 mesi, il bambino comincia ad avvertire che lui e la madre sono entità fisiche separate, con distinte esperienze affettive (Spitz ® comparsa del “sorriso sociale”). Questo nuovo senso del Sé opera ancora al di fuori del senso di consapevolezza. In questo periodo, inoltre, il bambino acquisisce la capacità di percepirsi come entità fisica unitaria dotata di coesione. Il bambino, in qualche modo, è portato a mettere un certo “ordine” al proprio mondo. Tutto ciò fa riferimento a esperienze precise.
2.13.5.2.2. SE AGENTE
2.13.5.2.3. SE DOTATO DI COESIONE
2.13.5.2.4. SE AFFETTIVO
2.13.5.2.5. SE STORICO
2.13.6. RUOLO DELLA MEMORIA
2.13.6.1. SENSO DEL SE SOGGETTIVO
2.13.6.1.1. Fra il 7° e l’8° mese di vita si assiste ad un altro salto evolutivo. Il bambino “scopre” che esistono delle menti oltre alla sua (intersoggettività tra bambino e genitore), inoltre compare l’attenzione, le intenzioni e gli stati affettivi nei confronti degli altri. In questo periodo è possibile sperimentare una “sintonizzazione affettiva” tra madre e bambino (fenomeno simile all’empatia).
2.13.6.2. SE VERBALE
2.13.6.2.1. Il bambino acquisisce maggiore autoriflessione, per esempio si riconosce allo specchio. Comincia inoltre ad utilizzare pronomi per riferirsi a sé; in sostanza, comincia ad utilizzare il linguaggio.
2.13.6.3. SE NARRATIVO
2.13.6.3.1. In questo periodo il bambino comincia ad utilizzare il linguaggio per costruire una narrazione della propria storia, una sorta di autobiografia. Questo stadio, da come si può dedurre, è di grande importanza per il trattamento analitico.
2.14. PRODROMI DELLA PSICOANALISI
2.14.1. VON SCHELLING
2.14.2. VON SHUBERT
2.14.3. SHOPENHAUER
2.14.4. VON HARTMANN
2.14.5. FRIEDRICH NIETZSCHE
2.15. SÁNDOR FERENCZI. I
2.16. ALFRED ADLER.
2.17. PSICOLOGIA DEL SE
2.17.1. JAMES
2.17.2. JUNG
2.17.3. FREUD
2.17.4. HARTMANN
2.17.5. JACOBSON
2.17.6. SULLIVAN
2.18. TEORIA DELL'INTERSOGGETTIVITÀ
2.19. IL MOVIMENTO RELAZIONALE
2.19.1. MITCHELL
