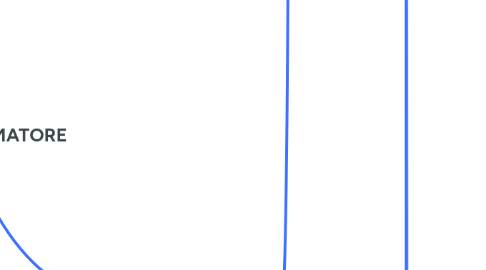
1. OBIETTIVI?
1.1. Ha come fine quello di comprendere il comportamento dei consumatori e per formulare politiche pubbliche e strategie aziendali più efficaci
1.2. Illustrare in che modo il consumatore decide di impiegare il proprio reddito nell’acquisto di beni, conoscendo i prezzi di mercato.(SCELTA DEL PANIERE)
1.3. Studiare come varia la domanda di un certo bene al variare del reddito e del prezzo relativo. (STUDI DELLA DOMANDA)
2. MODELLI UTILIZZATI
2.1. DUE BENI
2.1.1. OBIETTIVO CONSUMATORE
2.1.1.1. Raggiungimento del massimo beneficio possibile dati i propri bisogni, le proprie credenze e le propri opinioni
2.1.1.2. Il consumatore deve essere razionale e seguire le preferenze e i vincoli
2.1.2. COMPORTAMENTO CONSUMATORI
2.1.2.1. I beni i cui prezzi aumentano vengono sostituiti da beni che soddisfano gli stessi bisogni e hanno prezzi inferiori (modifica della composizione del paniere di consumo)
2.1.2.2. Al crescere del reddito disponibile, aumenta il consumo di tutti i beni del paniere, e in particolare di quelli di qualità superiore (modifica delle quantità di beni nel paniere)
2.1.3. TIPOLOGIE DI BENI
2.1.3.1. TIPOLOGIE DI BENI IN BASE ALLE PREFERENZE
2.1.3.1.1. Rispettano gli assiomi della Razionalità ma non sempre quelli Psicologici
2.1.3.1.2. CLASSIFICAZIONE BENI
2.1.3.2. TIPOLOGIE DI BENI IN BASE AL REDDITO
2.1.3.2.1. BENI NORMALI
2.1.3.2.2. BENI INFERIORI
2.1.4. PREFERENZE CONSUMATORE
2.1.4.1. Le preferenze sono le ragioni alla base di un comportamento, i motivi che danno conto delle azioni che si compiono in una data circostanza. Le preferenze determinano se una scelta mi dà maggiore benessere (utilità) o meno, inoltre dipendono da ciascuno di noi, diremmo dai nostri gusti e non dai prezzi di mercato. Si considera il consumatore come sempre razionale.
2.1.4.2. PREFERENZE REGOLARI
2.1.4.2.1. COSA SONO?
2.1.4.2.2. STRUTTURA
2.1.5. VINCOLO DI BILANCIO
2.1.5.1. Corrisponde al vincolo di disponibilità di risorse per il consumatore cioè la relazione che esprime tutte le combinazioni possibili di beni il cui valore totale non supera il reddito.
2.1.5.2. FORMULA
2.1.5.2.1. R = pa * qa + pb * qb
2.1.5.2.2. Da questa formula si ricava q, p o R
2.1.5.3. CARATTERISTICHE RETTA DI BILANCIO
2.1.5.3.1. Intercetta con asse x definisce quantità max di un bene
2.1.5.3.2. Intercetta con asse y definisce quantità max dell'altro bene
2.1.5.3.3. Il Coefficiente Angolare è il rapporto tra i prezzi dei due beni
2.1.5.4. SUDDIVISIONE PIANO CARTESIANO
2.1.5.4.1. Al di sotto del vincolo di bilancio
2.1.5.4.2. Sul vincolo di bilancio
2.1.5.4.3. Sopra il vincolo di bilancio
2.1.5.5. CAUSE VARIAZIONE VINCOLO DI BILANCIO (Statica Comparata)
2.1.5.5.1. Causa Variazione Reddito
2.1.5.5.2. Causa Variazione Prezzi dei Beni
2.1.5.5.3. CARATTERISTICHE
2.1.6. CURVA D'INDIFFERENZA
2.1.6.1. COS'E'?
2.1.6.1.1. Sono Curve di Livello della Funzione di Utilità che esprimono la stessa utilità all'interno della Funzione di Utilità e di conseguenza esprimono graficamente le Preferenze Regolari
2.1.6.2. CARATTERISTICHE
2.1.6.2.1. Sono curve di livello che crescono verso nord-est al crescere delle preferenze
2.1.6.2.2. Si hanno curve d'indifferenza se le preferenze sono razionali quindi se soddisfano l'assioma economico di transitività e completezza e quello matematico di continuità
2.1.6.3. COSTRUZIONE TOERICA DELLA CURVA
2.1.6.3.1. Si costruisce sulla base delle preferenze regolari
2.1.6.4. RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA
2.1.6.4.1. COS'E'?
2.1.6.4.2. CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE CURVE D'INDIFFERENZA
2.1.7. SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUZIONE (SMS)
2.1.7.1. COS'E'?
2.1.7.1.1. Concettualmente, dati due beni (B1 e B2), corrisponde alla quantità di B1 che il consumatore è disposto a rinunciare per ottenere un'unità supplementare di B2
2.1.7.1.2. Geometricamente è la pendenza della retta tangente alla curva d'indifferenza nel punto considerato
2.1.7.2. FORMULA | SMSab |
2.1.7.2.1. | -delta qb / delta qa |
2.1.7.2.2. SMSxy = Δx / Δy
2.1.7.3. ESEMPIO
2.1.8. FUNZIONE DI UTILITA'
2.1.8.1. La funzione di utilità si basa sul concetto di Utilità Ordinabile. Corrisponde ad un'utilità il cui peso è dato solo dall'ordine dei panieri e non dal di preferenza di un paniere in confronto ad un altro
2.1.8.1.1. All'interno del concetto di Utilità Ordinabile, viene meno il significato e senso dell'Utilità Marginale (esempio delle fette di pizza: più fette di pizza si manggiano minore sarà l'utilità ottenuta per fetta di pizza mangiate)
2.1.8.2. COS'E'?
2.1.8.2.1. Serve ad associare un numero ad un paniere
2.1.8.2.2. Teoricamente
2.1.8.2.3. Algebricamente
2.1.8.2.4. Geometricamente
2.1.8.3. RAPPORTO CON CURVE D'INDIFFERENZA
2.1.8.3.1. Le Curve d'Indifferenza sono le Curve di Livello della Funzione di Utilità
2.1.8.3.2. COME SI CALCOLA?
2.1.8.4. RAPPORTO CON SMS
2.1.8.4.1. SMSx,y = - (UMx / UMy)
2.1.8.4.2. CARATTERISTICHE
2.1.8.5. OPERAZIONI CON FUNZIONE DI UTILITA'
2.1.8.5.1. Trasformazione Monotona
2.1.8.5.2. Problemi di Massimizzazione Vincolata
2.1.8.6. PARTICOLARI FUNZIONI DI UTILITA'
2.1.8.6.1. Cobb - Douglas
2.1.8.6.2. Leontief
2.1.8.6.3. Funzioni Quasi Lineari
2.1.9. SCELTA OTTIMA DEL CONSUMATORE
2.1.9.1. La scelta ottima del consumatore può essere rappresentata come un processo di massimizzazione di una funzione di utilità che rappresenta le sue preferenze
2.1.9.2. CARATTERISTICHE
2.1.9.2.1. Deve trovarsi sul Vincolo di Bilancio, in quanto altrimenti non sarebbe ottenibile
2.1.9.2.2. Si trova sul punto di tangenza tra Vincolo di Bilancio e Curva d'Indifferenza più alta in quanto indica la preferenza massima quindi al rapporto tra i prezzi
2.1.9.2.3. E' un metodo attuabile con tutte le tipologie di beni
2.1.9.3. SISTEMA DI FORMULE
2.1.9.3.1. 1. Vincolo di Bilancio 2. | SMSab | = pa / pb
2.1.10. DOMANDA DI BENI DEL CONSUMATORE
2.1.10.1. TIPOLOGIE CURVE DI DOMANDA
2.1.10.1.1. DOMANDA INDIVIDUALE
2.1.10.1.2. DOMANDA AGGREGATA (Curva di Domanda di Mercato)
2.1.11. ELASTICITA' (E)
2.1.11.1. CARATTERISTICHE GENERALI
2.1.11.1.1. Serve per comprendere l'andamento di mercato
2.1.11.1.2. Dipende da:
2.1.11.2. ELASTICITA' DELLA DOMANDA
2.1.11.2.1. COS'E'?
2.1.11.2.2. CARATTERISTICHE
2.1.11.2.3. TIPOLOGIE
2.1.11.2.4. EFFETTI CAUSATI
2.1.11.3. ELASTICITA' DELL'OFFERTA
2.1.11.3.1. Misura la variazione percentuale nella quantità offerta di un bene o servizio in risposta a una variazione percentuale del prezzo di quel bene o servizio
2.1.12. OFFERTA DI LAVORO
2.1.12.1. COS'E'?
2.1.12.1.1. E' un concetto che descrive la quantità di lavoro che i lavoratori sono disposti a fornire ad un determinato salario
2.1.12.2. CARATTERISTICHE
2.1.12.2.1. L'offerta di lavoro è direttamente proporzionale al salario, il che significa che a un salario più elevato corrisponde una quantità maggiore di lavoro offerta
2.1.12.2.2. EFFETTO SOSTITUZIONE
2.1.12.2.3. EFFETTO REDDITO
2.1.12.2.4. Prevale l'effetto in base alle preferenze
2.1.12.3. Formule
2.1.12.3.1. Sono in ordine di utilizzo
2.1.12.3.2. Formula dell'Offerta di Lavoro
2.1.12.3.3. Formula del Numero di ore Lavorate (N)
2.1.12.3.4. Formula del Calcolo del Consumo (C)
2.2. TRE BENI
2.2.1. Valgono le stesse regole dei modelli a due beni, ma si aggiunge un asse, quello Z. Diventa così tridimensionale e vi è l'aggiunta di nuove caratteristiche
2.2.1.1. ESEMPIO MODELLO 3D
2.2.1.2. Il perso di anlaisi è opposto a quello a due beni
2.2.2. PREFERENZE RIVELATE
2.2.2.1. TEORIA ALLA BASE
2.2.2.1.1. Teoria delle Preferenze Rivelate (P. Samuelson)
2.2.2.2. PRINCIPIO ALLA BASE
2.2.2.2.1. Principio delle Preferenze Rivelate
2.2.2.2.2. ESEMPIO
2.2.2.3. UTILITA'
2.2.2.3.1. Le preferenze rivelate esprimono la relazione tra il paniere effettivamente domandato in corrispondenza ad un determinato vincolo di bilancio e i panieri che sarebbero potuti essere domandati in corrispondenza dello stesso vincolo di bilancio
2.2.2.3.2. ESEMPIO
2.2.2.4. METODOLOGIA DI CLACOLO
2.2.2.4.1. GEOMETRICAMENTE
2.2.2.4.2. ALGEBRICAMENTE
2.2.3. COMPRARE E VENDERE
2.2.3.1. CARATTERISTICHE
2.2.3.1.1. Primo tassello della teoria dell’equilibrio economico generale (come si determina equilibrio economico di tutti i mercati)
2.2.3.1.2. Se non vi è rivendita allora sceglierò un bene ad un altro in base alle preferenze. Se vi è rivendita, scelgo il bene con valore di mercato maggiore
2.2.3.2. CURVA DI DOMANDA
2.2.3.2.1. Domanda Individuale
2.2.3.3. CURVA DI OFFERTA
2.2.3.3.1. Curva di Offerta Netta
2.2.3.4. APPLICAZIONI PRATICHE
2.2.3.4.1. OFFERTA DI LAVORO
2.2.3.4.2. DECISIONI INTERTEMPORALI
2.2.4. VARIAZIONE EQUIVALENTE E COMPENSATIVA
2.2.4.1. Servono per calcolare variazioni di utilità senza ricorrere al surplus del consumatore?
2.2.4.2. Variazione Compensativa
2.2.4.2.1. ESEMPIO
2.2.4.2.2. CARATTERISTICHE
2.2.4.2.3. La variazione compensativa del reddito è la variazione del reddito necessaria a riportare il consumatore sulla curva di indifferenza iniziale, poiché tale variazione è appena necessaria a compensare il consumatore della variazione del prezzo
2.2.4.3. Variazione Equivalente
2.2.4.3.1. E' la variazione del reddito che equivale esattamente, in termini di utilità, alla variazione del prezzo (corrisponde a quanto dobbiamo dare al consumatore per indurlo a non chiedere la riduzione di prezzo).
2.2.4.3.2. ESEMPIO
2.2.4.4. RAPPORTO TRA LE VARIAZIONI
2.2.4.4.1. Entrambe dipendono dalla variazione del reddito
2.2.4.4.2. La variazione equivalente e la variazione compensativa non sono uguali in generale. Quindi la stessa variazione di prezzo può avere un impatto diverso sul benessere del consumatore a seconda di quale di queste due grandezze utilizziamo per misurarlo.
2.2.4.4.3. Se le preferenze sono quasi-lineari (non c’e l’ER, infatti x e y’ sono allineati verticalmente) allora la variazione equivalente è uguale alla variazione compensativa. In questo caso diciamo che queste due grandezze sono il surplus del consumatore.
2.2.4.4.4. RICAPITOLANDO
