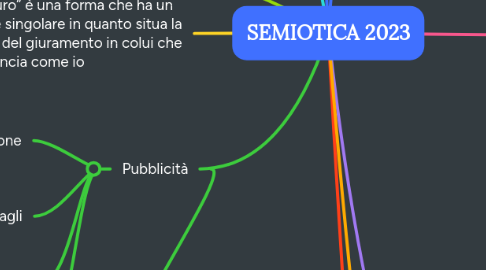
1. TEORIA SEMIOTICA DI SAUSSURE
1.1. segno
1.1.1. Per Saussure
1.1.1.1. è la relazione che si istituisce fra un concetto ed un'immagine acustica
1.1.1.1.1. significato
1.1.1.1.2. significante
1.2. a dare significato al segno è la struttura
1.2.1. STRUTTURALISMO
1.2.1.1. La lingua è fatta da non segni, da una serie di cose che non hanno senso e che lo assumono quando entrano associati ad altri
1.2.1.1.1. ciò che conta nella lingua non sono gli elementi che la compongono ma le relazioni che si creano tra di essi.
1.3. la lingua lavora su due piani, inscindibili (astratto e concreto)
1.3.1. lingua è sistema di differenze
1.3.1.1. organizza da un lato qualcosa di astratto e poi qualcosa di concreto come la possibilità di esprimerlo
1.3.2. lingua è sistema di relazioni
1.3.2.1. Saussure distingue tra
1.3.2.1.1. LANGAGE
1.3.2.1.2. LANGUE
1.3.2.1.3. PAROLE
1.4. Semiologia
1.4.1. disciplina che studia i sistemi con cui l'uomo comunica
1.4.1.1. studia il quadro della vita dei segni
2. semiotica, dal greco “semeion” che vuol dire “segno”, è la disciplina che studia i sistemi di significazione.
2.1. segni funzionano perchè si intrecciano creando testi
2.2. la semiotica si basa su quattro livelli d’azione:
2.2.1. EPISTEMOLOGICO: relativo agli assetti generali del sapere
2.2.2. TEORICO: (o filosofico) che mira a ripensare dalle fondamenta alcune categorie chiave legate alla conoscenza, all’etica e all’estetica;
2.2.3. METODOLOGICO: uno strumento flessibile di categorie e modelli interdefiniti tra loro;
2.2.4. EMPIRICO: legato alla conoscenza personale e non ad un apprendimento
2.3. tre momenti dell'analisi semiotica:
2.3.1. segmentazione degli elementi
2.3.2. classificazione degli elementi
2.3.3. riarticolazione (consapevolezza del funzionamento del prodotto culturale)
2.4. tre paradossi
3. JAKOBSON
3.1. Esistono fonemi, mattoni sui quali edificare qualcosa di più grande
3.1.1. 12 coppie di tratti
3.1.1.1. tratti sono la sostanza dell'espressione
3.1.1.1.1. trova i tratti che combinati tra loro possono formare i fonemi
3.1.1.2. fonemi sono la forma dell'espresisione
3.1.1.2.1. astratti, non si ritrovano nella lingua
3.1.2. con i tratti si possono descrivere tutte le lingue del mondo
3.1.3. a comporre fonemi erano le proprietà
3.2. modello di comunicazione
3.2.1. varie funzioni
3.2.1.1. funzione emotiva (mittente)
3.2.1.2. funzione conativa (destinatario)
3.2.1.3. funzione emotiva (messaggio)
3.2.1.4. funzione metalinguistica (codice)
3.2.1.5. funzione fatica (canale)
3.2.1.6. funzione referenziale (contesto)
3.2.2. Distinguiamo tre modi di interpretazione di un segno linguistico:
3.2.2.1. TRADUZIONE ENDOLINGUISTICA o RIFORMULAZIONE→ traduzione di una determinata lingua attraverso quella lingua stessa (es. chiarire un concetto attraverso la parafrasi)
3.2.2.2. TRADUZIONE INTERLINGUISTICA → è la traduzione propriamente detta, ovvero l’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di un’altra lingua;
3.2.2.3. TRADUZIONE INTERSEMIOTICA o TRASMUTAZIONE→ si realizza quando un contenuto espresso in un sistema linguistico viene reso attraverso un altro sistema linguistico (es. un film tratto da un romanzo).
4. TEORIA SEMIOTICA DI HJELMSLEV
4.1. Il segno corrisponde alla relazione tra due piani che costituiscono la struttura del linguaggio umano
4.1.1. piano del contenuto
4.1.2. piano dell'espressione
4.1.2.1. espressione e contenuto sono in reciproca relazione ma non sono conformi
4.1.2.1.1. non c'è logica che li unisca
4.1.2.1.2. separazione dei due piani nell'analisi
4.2. Distinzione tra
4.2.1. segno
4.2.1.1. entità che esprime relaz. tra espressione e contenuto
4.2.1.1.1. non conformità tra i piani, essendo espressione e contenuto formati in modo diverso, biplanare
4.2.2. simbolo
4.2.2.1. efficace se è facilmente riconoscibile
4.2.2.1.1. conforme, monoplanare
4.2.3. semi-simbolo
4.2.3.1. relazione segnica che si costituisce tra categorie sul piano dell’espressione e categorie sul piano del contenuto
4.2.3.1.1. sono biplanari, c’è conformità tra piani→ particolare relazione segnica che si costituisce tra categorie sul piano dell’espressione e categorie sul piano del contenuto
4.3. MATERIA è l'elemento che accomuna le lingue
4.3.1. ogni lingua articola una materia e la organizza per produrre significazione
4.3.2. materia è precedente alla lingua
4.4. Distinzione tra
4.4.1. Denotazione
4.4.1.1. semiotica che presenta un piano dell’espressione e un piano del contenuto Pane/mafalda
4.4.2. Connotazione
4.4.2.1. semiotica che presenta un piano della semiotica stessa (volpe:animale e furbizia)
4.4.3. Metalinguaggio
4.4.3.1. ci si aggancia al piano del contenuto (linguaggio che ha sé stesso come contenuto e una lingua parla di sé stesso) es. parlare di cucina tramite cibi
4.5. idea di non sapere viene messa in forma (attraverso la grammatica) e si produce una sostanza del contenuto (il modo in cui ciascuna lingua articola l'idea di “non sapere”)
4.5.1. mC->fC->sC
4.5.1.1. La materia è il prelinguistico, la forma è un’operazione, la sostanza è ciò che viene prodotto.
4.5.1.1.1. c'è forma del
4.5.1.1.2. primarietà della forma!!
4.5.2. Essendoci tanti suoni la materia sonora è un inarticolato insieme di possibili suoni
4.5.2.1. Le lingue isolano alcuni suoni che diventano fonemi, dei mattoncini che non coincidono da lingua a lingua
4.5.2.1.1. Ogni lingua costruisce i propri mattoni delle parole
5. TEORIA SEMIOTICA DI PEIRCE
5.1. Segno
5.1.1. Un segno è qualcosa che sta per qualcos’altro a qualcuno in qualche modo
5.1.1.1. “Definisco un segno come qualcosa che da un lato è determinato da un oggetto e dall’altro determina un’idea nella mente di una persona, (interpretante del segno) è con ciò stesso mediamente determinata da quell’oggetto”.
5.1.2. Il significato è il segno in cui esso deve venire tradotto per essere compreso
5.1.3. classificazione dei segni
5.1.3.1. indice
5.1.3.1.1. il segno ha un rapporto di contintuità fisica con l'oggetto
5.1.3.2. icona
5.1.3.2.1. il segno ha un rapporto di somiglianza con l'oggetto
5.1.3.3. simbolo
5.1.3.3.1. il segno ha un rapporto convenzionale con l'oggetto
6. Pubblicità
6.1. lo scopo è la persuasione
6.2. si arriva a ciò facendo acquistare valore agli oggetti di cui si parla
6.2.1. si trasforma il destinatario in consumatore
6.3. pubblicità è costituita da qualcosa che il destinatario si aspetta (ECO)
6.4. FLOCH
6.4.1. 4 valorizzazioni
6.4.1.1. • Valorizzazione pratica: oggetto viene considerato per il suo carattere di strumento • Valorizzazione utopica: attenzione al soggetto che ricongiungendosi con l’oggetto di valore, realizza la sua identità, opinione soggettiva • Valorizzazione critica: opinione oggettiva; l’obiettivo è quello di oggettivare il prodotto esplicitando il prezzo. • Valorizzazione ludica: prodotto visto non come mezzo di trasporto ma come mezzo di piacere
6.5. SEMPRINI
6.5.1. mapping
6.5.1.1. sistema logico che oppone, incrociandole, due categorie differenti
6.5.1.2. dal pratico e utopico si ricavano valori critici e ludici come qualificazioni e spiegazioni dei primi
6.5.1.3. mapping permette di riempire progressivamente la distanza che separa il pratico dal critico, o il critico dal utopico.
7. Morfologia delle fiabe
7.1. Intorno al 1800
7.2. identità di un popolo viene fuori dalle tradizioni popolari
7.2.1. fiabe si tramandavano da secoli oralmente
7.2.1.1. ora si pone il problema di trascriverle e di classificarle
7.2.1.1.1. due problemi
7.2.1.1.2. VLADMIR PROPP
7.2.1.1.3. GREIMAS
8. “Io giuro” è una forma che ha un valore singolare in quanto situa la realtà del giuramento in colui che si enuncia come io
9. Quadrato semiotico
9.1. il valore di un segno si dà sempre per differenza
9.1.1. differenze producono significazione
9.1.2. ogni narrazione ruota intorno a un’opposizione
9.2. non maschio non coincide sempre con femmina
9.2.1. si arriva quindi da un termine al suo contradditorio attraverso un’operazione di negazione
9.2.1.1. crea opposizione privativa
9.2.1.1.1. maschile e non femminile + femminile e non maschile sono complementari
10. LINGUISTICA
10.1. segno linguistico
10.1.1. due principi fondamentali
10.1.1.1. arbitrarietà (Il segno linguistico è arbitrario a priori, è necessario a posteriori e subisce variazioni in base all’uso)
10.1.1.2. linearità (il significante acustico è lineare, cioè non riusciamo a vocalizzare due parole allo stesso momento)
